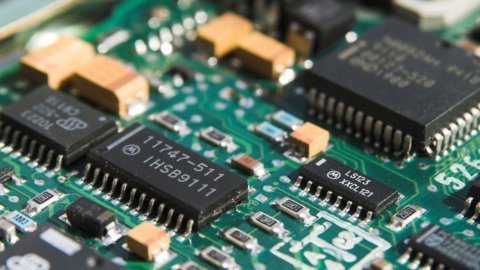La quota del mercato dei chips controllata dagli Stati Uniti dieci anni fa era pari al 37 per cento del totale. Nel 2010 è scesa al 12 per cento. Nello stesso periodo l’Europa è passata dal 35 al 8 cento del mercato. La Cina, in pratica assente dalla scena fino alla fine degli anni Novanta, oggi controlla il 15 per cento, destinato a salire entro la fine del decennio al 24 per cento. Intanto, i tre quarti della produzione mondiale di semiconduttori, la materia prima di base dell’industria nell’era dell’elettronica, è concentrata nel Far East, sotto il controllo di due big, la taiwanese Tmsc e la coreana Samsung, e di alcuni concorrenti giapponesi e cinesi.
Ecco la fotografia di una realtà scomoda e pericolosa perché, tra l’altro, oggi non è possibile nemmeno immaginare la produzione di un’auto senza disporre dei chips necessari. Come stanno scoprendo tutte le case automobilistiche a partire da Volvo che ieri ha lanciato l’allarme, avvertendo il mercato che non riuscirà a raggiungere, causa la penuria di chips, la produzione promessa per il 2021, un warning che è costato un tonfo del 7% al gruppo svedese controllato dai cinesi di Geely. In casa Volkswagen la mancata consegna dei chips costerà quest’anno 100 mila vetture. Ma, ammonisce Mediobanca Securities, tutti i produttori dovranno rivedere al ribasso le proprie stime, frustrando così in parte le prospettive di ripresa del mercato. Previsioni, certo, troppo caute all’origine della crisi attuale. Tutte le case, nell’incertezza attuale, hanno scelto di prenotare solo quantitativi modesti di chips contando di poter integrare la domanda all’ultimo momento. Ma, ahimè, l’auto non è la sola né la più importante cliente sul mercato: prima vengono, ad esempio, i gruppi del gaming come Nintendo o la stessa Microsoft che, forti del boom della domanda di giochi elettronici ai tempi del lockdown, hanno moltiplicato gli ordini a tempo debito.
Questa cornice spiega l’entusiasmo con cui Wall Street ha accolto la notizia, comunicata a mercato chiuso, che Intel intende dare il via a due nuove fabbriche di chips sul territorio americano con un investimento complessivo di 20 miliardi di dollari con l’obiettivo di riportare in Usa almeno una parte della produzione, ribaltando così la strategia che finora ha concentrato in patria solo il design e l’architettura dei chips poi prodotti nel Far East. Una mossa dal sapore politico-strategico che Wall Street ha accolto con un robusto rialzo, superiore al 7 per cento, nel dopo Borsa. Un rally che prosegue stamane sui listini europei: il settore Tecnologico è sotto i riflettori nella seduta odierna con un rialzo del 2,2% sostenuto dai colossi dei semiconduttori: Asm +7%, Asml +6%, BE Sem. +4%, Infineon +2%. L’italo francese Stm, che ha appena staccato l’ultima tranche di dividendo, avanza dell’1,5%.
La rivincita dell’Occidente, in realtà, appare complessa, sia sul piano economico che tecnologico. Secondo una ricerca di Boston Consulting, una nuova fabbrica di chips in Usa finisce per costare, al termine del primo ciclo di produzione (dieci anni) un terzo in più rispetto a Taiwan, Singapore e la Corea del Sud. Contano vari fattori tra cui la concentrazione geografica: per Tmsc (probabilmente la società più importante e meno conosciuta per il funzionamento dell’economia globale) non costa granché spostare in giornata un ingegnere da una fabbrica all’altra che dista poche decine di chilometri. Intanto in Cina a far la differenza sono i generosi contributi pubblici concessi ai nuovi impianti, che finiscono per costare un 50 per cento in meno rispetto agli Stati Uniti. Anche per questo dal 2015 la Cina ha annunciato il varo di 84 nuove fabbriche, per più della metà fonderie rivolte alla prodizione. Più del doppio di quanto previsto ad Ovest, dove si è privilegiato l’aspetto del design di nuovi modelli.
Ma non per questo è meno importante il gap tecnologico accumulato da americani ed europei. Le nuove fabbriche in costruzione a Shenhua, nell’isola di Taiwan, prevedono pezzi da 3 nanometri, ovvero 1/20.000 di spessore di un capello umano, per ospitare i chips, contro gli attuali 7 nanometri di Intel che accusa costi di produzione tra l’8 ed il 10 per cento in più.
E l’Europa? Nel Vecchio Continente non mancano le eccellenze. Infineon, Stm e Nxp hanno sviluppato un grande know how sul disegno dei chips destinati all’auto. Ma anche in Europa, causa i costi e la relativa distanza dai clienti finali (gli smartphone, ad esempio) si è accumulato un ritardo nella manifattura che solo ora sotto la regia dell’Unione Europea, si cerca di ridurre. Anzi, il piano europeo conta di conquistare la leadership con l’obiettivo di mettere a punto fabbriche capaci addirittura di produrre chips da 2 nanometri, ad un passo dal limite della legge di Moore. Ma il progetto non convince tutti. “Oggi noi produciamo chips da 22 nanometri – spiega un tecnico del settore – passare da 22 a 2 nanometri presenta un altissimi rischio di crash. E’ come fare un salto dalla cima di un grattacielo”. Senza dimenticare che quella dei chips è un’industria che richiede investimenti continui e sempre più costosi. Ma necessari soprattutto per chi, come la vecchia Europa, vuole conservare almeno un primato industriale, quello dell’auto.