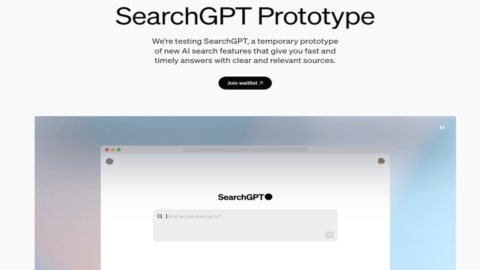Si sta facendo strada in Italia l’idea che la causa di tutti i nostri mali sia l’Unione europea e che basti uscirne per tornare a un’era felice di sovranità nazionale in cui tutti i problemi scompaiono. Basterebbe in sostanza liberarsi dai “vincoli europei” per riattivare la crescita dell’economia, dei consumi e degli investimenti, sconfiggere la disoccupazione, risollevare la competitività e la produttività delle nostre imprese. Ma in realtà i vincoli europei sono solo l’ultimo capitolo di una storia pluridecennale in cui l’Italia non riesce ad affrontare le cause di fondo delle sue debolezze economiche e sociali, ricorre alla svalutazione della moneta e ai deficit della finanza pubblica per tirare a campare, precipita in una crisi finanziaria, richiede e ottiene assistenza dai suoi alleati assoggettandosi a un “vincolo esterno”, con la promessa che “farà la brava”. Ma appena la situazione migliora, l’Italia cerca di scrollarsi di dosso i vincoli e ritorna sulla cattiva strada della spesa pubblica distribuita a pioggia, fino alla crisi successiva.
Questa sequenza deprimente l’Italia l’ha vissuta tre volte dopo il miracolo economico degli anni Cinquanta e Sessanta. La prima volta negli anni Settanta, dopo il crollo del regime dei cambi stabili di Bretton Woods, la svalutazione del dollaro e la crisi petrolifera. La lira, lasciata alle forze del mercato, si svalutò ampiamente e le riserve valutarie si assottigliarono per effetto di persistenti deflussi di capitale. Non vi fu alternativa al ricorso al Fondo monetario internazionale che concesse ben quattro prestiti all’Italia tra il 1974 e il 1979 in cambio di una serie di condizioni di politica economica (il vincolo esterno!) mirate al risanamento della finanza pubblica e alla riduzione del deficit della bilancia dei pagamenti.
La crisi fu tamponata, ma le svalutazioni della lira portarono l’inflazione alla fine degli anni Settanta al 22 per cento: è il bello della sovranità monetaria, cari amici! Con i tassi d’interesse al 15 per cento, era impossibile farsi dare un mutuo per la casa, ma in compenso si poteva investire in BOT e BTP perdendo un 5-6 per cento in termini reali (al netto dell’inflazione). Ma tanto nessuno se ne accorgeva per effetto di quella che gli economisti chiamano “illusione monetaria”.
Negli anni Ottanta, l’Italia aderì al Sistema monetario europeo (SME) per riportare sotto controllo l’inflazione galoppante. Accettammo l’impegno ad attuare una severa politica monetaria e a limitare le svalutazioni della lira. L’inflazione scese gradualmente, senza però riuscire ad andare sotto allo “zoccolo duro” del 5 per cento. Ciò perché in quegli anni i governi (specie quelli sotto la presidenza Craxi) attuarono una politica fiscale fortemente espansiva, con disavanzi fiscali dell’ordine del 10-12 per cento del prodotto interno lordo (PIL) ogni anno dal 1981 al 1993. Come dovrebbe essere ovvio, il disavanzo di oggi diventa il debito di domani, e il peso del debito pubblico sul PIL raddoppiò passando dal 59 per cento del 1981 al 118 per cento nel 1994. Questa cura da cavallo di spesa pubblica in deficit non ebbe gli effetti sperati sulla crescita e sull’occupazione né servì a risanare le nostre debolezze strutturali. Per contro, l’insostenibile pesantezza del debito si scaricò sul cambio della lira che dovette uscire dallo SME nel 1992.
Si aprì una nuova stagione di svalutazioni del cambio, culminata con la maxi svalutazione del primo trimestre del 1995. Ma nel frattempo il governo aveva sottoscritto, e il Parlamento aveva ratificato, il Trattato di Maastricht sull’Unione economica e monetaria. L’Italia si impegnò a tenere il disavanzo fiscale entro il 3 per cento del PIL e a riportare il debito pubblico al 60 per cento del PIL; il governo prese misure per soddisfare i criteri di Maastricht e l’Italia fu ammessa nell’Unione economica e monetaria il 1° gennaio 1999. I nostri partner accettarono che la conversione della lira in euro avvenisse a un tasso di cambio che incorporava gran parte delle svalutazioni accumulate negli anni precedenti e si fidarono dell’impegno assunto di risanare le finanze pubbliche.
Ma le cose andarono diversamente. Inizialmente, l’ingresso nell’euro spinse al ribasso i tassi di interesse sul debito pubblico italiano, contribuendo a ridurre il disavanzo fiscale; inoltre, una moderata crescita del reddito e un’inflazione in media superiore al 2 per cento portarono a una graduale diminuzione del peso del debito sul PIL al 100 per cento nel 2007. Ma a quel punto la tendenza si invertì e il peso del debito riprese a salire. È stato calcolato che se l’Italia avesse mantenuto le politiche di risanamento delle finanze pubbliche con la stessa intensità introdotta nel 1999, il peso del debito sul PIL sarebbe sceso nel 2007 al 70 per cento, il che ci avrebbe consentito di assorbire meglio e di reagire con maggiore efficacia alla crisi finanziaria globale che esplose nel 2007-09. Invece l’impatto della crisi sul nostro debito pubblico fu devastante: la combinazione di caduta del reddito, di deflazione e di politiche fiscali complessivamente accomodanti fece di nuovo salire il peso del debito al 132,6 per cento del PIL nel 2016.
Colpa dei vincoli europei? L’evidenza non lo conferma: in realtà l’Italia è l’unico paese dell’eurozona che cresce meno dell’1 per cento, a parità di vincoli con gli altri paesi aderenti alla moneta unica. Il fattore discriminante sembra dunque essere proprio la zavorra del debito pubblico che assorbe risorse che potrebbero essere meglio impiegate per correggere le debolezze strutturali del nostro sistema economico e per rafforzare il potenziale di crescita. Senza i vincoli, cosa avremmo fatto? Più svalutazioni, più deficit, più debito pubblico? Tutte cose già sperimentate in abbondanza senza successo e che avrebbero solo rinviato nel tempo la resa dei conti, nel frattempo divenuti sempre più salati.
Forse, se avessimo preso sul serio i vincoli, anziché cercare sempre di aggirarli, avremmo raggiunto i risultati che altri paesi hanno conseguito, il Belgio, la Spagna, l’Irlanda, per esempio. Come ci è stato più volte raccomandato dalle istituzioni europee, bisognava adottare una strategia di risanamento intensa ma di breve durata in modo da limitare nel tempo i sacrifici e l’austerità, e ottenere rapidamente i benefici attesi. Si è invece preferito diluire, attenuare, rinviare, nella vana speranza che col tempo tutto si aggiusta.
D’altra parte, è stata proprio l’esperienza della crisi globale a dimostrare che era stato saggio per l’Italia aderire alla moneta unica. L’euro ci ha protetto da turbolenze finanziarie che avrebbero avuto effetti disastrosi sulle nostre finanze pubbliche: invece, i tassi di interesse sono rimasti bassi e abbiamo beneficiato della politica monetaria espansiva della BCE; l’euro si è indebolito marginalmente ma abbastanza per dare un impulso alle nostre esportazioni. In sintesi, abbiamo rinunciato a una illusoria sovranità monetaria a livello nazionale, in cambio di una ben più efficace sovranità a livello europeo.
Accettare i vincoli europei ha consentito all’Italia di avere accesso col Trattato di Roma del 1957 al grande mercato unico europeo, nel solco di una tradizione che ha visto sin dal Rinascimento i mercanti, i banchieri, gli architetti e i musicisti italiani operare proficuamente nelle grandi nazioni europee. E l’idea di ancorare l’Italia all’Europa non è il frutto di recenti macchinazioni di tecnocrati, ma di statisti del calibro di Mazzini, Cavour, Einaudi, De Gasperi. Uscire dall’impresa europea che ha consentito all’Italia di trasformarsi nel dopoguerra da paese agricolo e sottosviluppato in paese industrializzato avanzato, tanto per liberarsi dai vincoli che essa comporta, sarebbe un atto autolesionistico di gravità inaudita. Tanto vale, quindi, riconoscere una volta per tutte che i vincoli europei fanno bene all’Italia perché frenano l’inclinazione della nostra classe politica, ma anche della società civile, a fare cose che non ci giovano. Svalutazione della
moneta e spesa pubblica a pioggia sono come due droghe che danno al tossicodipendente una temporanea sensazione di benessere, ma ne minano la fibra e indeboliscono gli organi vitali. Le regole europee avrebbero dovuto, se le avessimo prese sul serio, disintossicare e rafforzare la salute del paese.
In realtà, per come le abbiamo gestite, hanno solo prolungato la crisi di astinenza, colpevolmente alimentata da chi ha seminato continue illusorie speranze di rinegoziare il tasso di cambio, di flessibilizzare le regole fiscali, di uscire dall’euro. Si dice che Giovanni Giolitti, capo del governo della “nuova Italia” tra le fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, ritenesse che l’Italia fosse un paese deforme, con la gobba, e che non potesse indossare un abito fatto per gente con la schiena dritta. Bisognava fargliene uno apposta. Ma la storia del dopoguerra ha dimostrato che l’Italia non ha la gobba, è solo un po’ pigra e tende a rinviare al domani quel che dovrebbe fare oggi, ma che ha saputo reagire con forza e determinazione alle tante sfide che ha dovuto fronteggiare. Certo, la crisi economica e finanziaria innescata e propagata dalla globalizzazione è stata di una durezza senza precedenti, ma gettare alle ortiche l’abito europeo che l’Italia ha saputo indossare in tante occasioni con dignità ed eleganza, non l’aiuterà a uscirne.