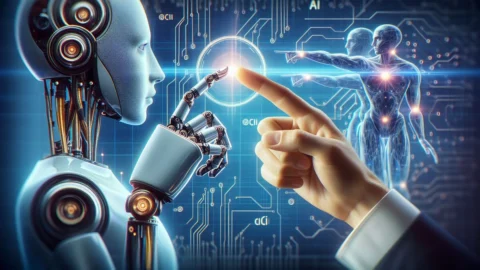THE ECONOMIST: 1° COMANDAMENTO, NON AVRAI ALTRO STILE CHE IL MIO
Per l’Economist tutto è una questione di stile. Il periodico di Londra, ora con vista sul Tamigi al Victoria Embankment, è anche un impressionante think-tank. Un think-tank ossessionato dallo stile. I suoi contenuti devono essere riconosciuti subito, come se fossero diffusi da un altoparlante, tipo proclama del duce.
A proposito di altoparlanti e duce, se avete un’oretta e mezzo godetevi il grande saggio di stile recitativo della coppia Loren-Mastroianni nel film di Ettore Scola Una giornata particolare (in streaming su Chili, euro 2,99). Se proprio non avete tempo, o se l’avete già visto, come è probabile, guardatevi almeno la scena della rumba (un minuto e mezzo) su YouTube. Cinema (pardon, cinematografo, direbbe Robert Bresson) al nono cielo. Neanche c’è la parola per dirlo.
CHI È?
Gli articoli dell’Economist non sono firmati e non sappiamo neppure chi sia il direttore del magazine. Non sia mai che ci affezioniamo allo stile di qualcuno… ! Apprendiamo il nome di un giornalista o di un direttore solo dal pezzo che ne annuncia la “dipartita” dal giornale.
Se questa “carboneria” vi dà fastidio, potrete alleviare il vostro spirito sul sito che riporta le succinte schede dei componenti dello staff editoriale. Sono un piccolo esercito. E, in ogni caso, non capirete mai chi ha scritto un determinato pezzo.
Comunque, all’Economist non esiste assolutamente nessuna carboneria, e il conflitto d’interessi è un sacrilegio per la testata. Gli stessi Agnelli, che detengono il 43,4% delle azioni, hanno appena il 20% di diritti di voto. E quando i giornalisti parlano della famiglia o della Exor sono obbligati a informare il lettore sulla posizione che la famiglia italiana riveste nella proprietà del giornale.
Se avete 8 minuti, magari non adesso, leggetevi che cosa scrive l’Economist di stesso (ve lo abbiamo tradotto in italiano).
LO STILE È IL CONTENUTO
Ogni estate la redazione dell’Economist rende disponibili alcune brevi tirocini per giovani aspiranti giornalisti. I candidati devono presentare, tra l’altro, un articolo di 600 parole, che è anche l’estensione media degli articoli del magazine.
L’argomento è a piacere, ma per lo stile esistono precise disposizioni. Scorrendole (vado però a memoria) mi sono fatto l’idea che, una volta esaudito il minimo sindacale, conti moltissimo il saper essere spiritosi e mai pomposi (attenzione!, epigoni di Cicerone).
Il fondatore Walter Bagehot (si pronuncia Bajut) chiamava tale approccio “expressive colloquialisms”. Bisogna usare molto Sidol per lucidare il pezzo da mandare all’Economist. Deve fluire come una palla da bowling lanciata da Jeffrey “Drugo” Lebowski .
GUARDATE VOI STESSI
Mica sto esagerando. Accertatevene voi stessi. È in rete. L’8 luglio scorso Lane Greene, language columnist, e Anton La Guardia, digital editor, hanno tenuto un webinar sul tema “Language and the principles of style at The Economist”. Un’ora e passa di lavaggio del cervello.
A guidare lo stile dello staff dell’Economist sono le famose sei norme elementari di scrittura di George Orwell. Se ne infrangete una qualsiasi, verga Orwell, “scriverete qualcosa di assolutamente ignobile”. Non solo! perderete ogni speranza di diventare tirocinanti all’Economist. Per chi voglia approfondire c’è anche questo da guardare.
Con una frequenza quasi bisettimanale, in una specifica rubrica chiamata “Johnson” – in onore di Samuel Johnson il solitario compilatore del Dizionario della lingua inglese del 1756, qualcuno della redazione del magazine discute, nell’ottica della filosofia del linguaggio dell’Economist, un tema linguistico o lessicale (della lingua inglese naturalmente).
CI VORREBBE UN VOCABOLARIO DI STILE
Quella dello stile è una faccenda molto seria per chiunque pubblichi qualcosa. Non c’è nulla di più sgraziato e greve che offendere una persona o mancarle di rispetto solo perché, molto semplicemente, abbiamo usato un linguaggio trascurato o un atteggiamento frettoloso.
Ci vorrebbe veramente un correttore automatico dello stile, capace di estrarre il tono giusto da un speciale vocabolario, magari redatto dagli accademici della Crusca.
Non voglio qui entrare nella questione del politicamente corretto (che trova la sua prima manifestazione nel linguaggio) perché ci porterebbe troppo lontano.
Voglio dire che il linguaggio del politicamente corretto (come pure di quello, specularmente, analogo, del politicamente scorretto) devono avere sempre uno stile che tenga alto il livello del discorso pubblico e privato. Ogni lingua ha un suo lessico, una sua sintassi e un registro linguistico per poterlo fare.
Nella lingua e nelle parole ci sono infinite possibilità come ci mostra da par suo Raymond Queneau e come ci dà una prova definitiva Umberto Eco con la sua magistrale traduzione in italiano degli Esercizi di stile di Queneau. 99 variazioni linguistiche di una stessa storia. Un numero che sarebbe piaciuto all’Economist.
T’e capì?, mica tutti hanno, però, le competenze linguistiche o i registri di Queneau, Eco o Bartezzaghi; comunque sia, perché accontentarsi di una seconda scelta a rischio di strafalcioni?
GOOGLE AIUTACI TU
Chi ci può aiutare? Chi, eh? Ma Google, naturalmente!
Pensate cosa ha fatto Google con “Translate” o con le correzioni quasi sempre adeguate, di parole digitate in modo approssimativo (soprattutto se ciò avviene in una lingua non materna) nella sua barra di ricerca. “Forse cercavi…”. Grazie Google! Poi, magari, ti segue come un ombra: ma, pazienza, va bene così.
Abbiamo assistenti alla scrittura che funzionano ormai piuttosto bene: controllano l’ortografia, la grammatica, suggeriscono sinonimi e completano tronconi di parole.
Adesso Google vuole scalare un’altra vetta. Lo scorso 18 maggio, Sundar Pichai, alla “Google I/O developer conference”, ha annunciato uno strumento on-line per implementare, nella sua suite di applicazioni “Google docs”, l’uso di un linguaggio inclusivo, spogliato da pregiudizi sessisti o razziali.
È disponibile in inglese e anche in altre lingue. Non ho capito invece se esista anche in italiano, ma arriverà di sicuro, a meno che Google (è già capitato molte altre volte), non lasci il progetto su un binario morto per acchiappare un altro treno.
GIOIA O NOIA?
In ogni lingua, al di là dei pronomi possessivi, ci sono espressioni che si usano solo per un genere ma non per l’altro. A volte sono neutre, altre volte sono epiteti e può accadere che, lì per lì, non venga in mente un’alternativa semplicemente perché non ne esiste una nel nostro bagaglio lessicale.
Non sempre il genere maschile include il genere femminile, come si pensava al tempo dei Flinstone. Impegnandosi un po’, potremmo fare senz’altro qualcosa di meglio. Adesso a ricordarcelo – con stile – c’è il Dizionario del linguaggio inclusivo di Google.
Grazie a questo dizionario on-line, tutto brillerà di più e saremo letti con più gioia, anche se qualcuno all’inizio penserà, magari fondatamente, “Uh, che noia!”.
L’annuncio di Google, infatti, ha subito infastidito il Daily Mail: “Google Docs goes woke” ha scritto il quotidiano di Londra, ma Google ha ricevuto il prudente plauso di Johnson.
Johnson ha, però, ragione a domandarsi se debba essere proprio una compagnia tecnologica a darci un vocabolario del linguaggio inclusivo. C’è da meravigliarsi? Ormai fanno tutto!
All’Economist non hanno certo bisogno di Google Docs per evitare strafalcioni sessisti. Il linguaggio inclusivo è come un cibo nuovo e un po’ esotico: ci devi pensare, ma alla fine lo inserisci nella tua dieta. Vi lascio con questa performance linguistica assolutamente inappropriata.