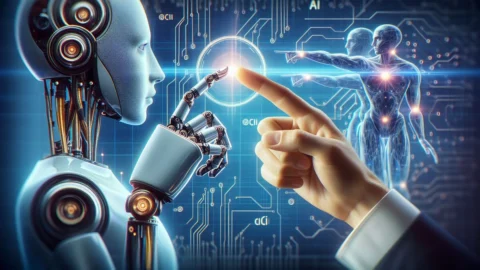Immaginare uno scenario culturale per l’Italia dei prossimi anni è davvero molto difficile. E iniziare un intervento sugli scenari culturali futuri con questa affermazione è davvero molto facile.
Lo sanno tutti che la cultura è il tesoro del futuro, ma nessuno sa come estrarla dal nostro sottosuolo. Come fossimo un paese ricchissimo di petrolio, o di miniere d’oro ma nessuno fosse in grado di estrarli e trasformarli in qualcosa di redditizio. Camminiamo ogni giorno sopra immensi tesori, e non sappiamo che farcene. Ma il paragone regge fino a un certo punto. È più facile estrarre petrolio, oro e diamanti e sapere cosa farne, piuttosto che valorizzare un patrimonio culturale e ricavarci ricchezza. Ed è più facile perché in realtà si tratta di ricchezze diverse, di patrimoni diversi, e di paradigmi diversi. Con il petrolio si va in macchina, ci si scalda, e si mandano avanti le aziende, con la cultura non si fa nulla di tutto questo. Come si diceva un tempo, si nutre lo spirito. Ma lo spirito, sopravvive anche se è fortemente denutrito, e questo lo sperimentiamo tutti noi ogni giorno della nostra vita, mentre se la macchina non si accende qualche problema ce lo crea. Questa premessa per dire che investire in cultura è un rischio non indifferente. Se lo leggiamo in termini imprenditoriali. Ed è più conveniente, non c’è dubbio, fare investimenti più redditizi, con meno rischio, e più facili.
La mia è chiaramente una provocazione, ma ha un suo fondamento. Fare affari con la letteratura, i musei, il cinema, i siti archeologici o quant’altro è un bel sogno, ma serve a poco. Soprattutto non serve a migliorare la cultura di un paese. Anzi, è deleterio. Ed è deleterio perché scambia il fine con il mezzo, capovolge una prospettiva, snatura le cose che contano, illude che tutto sia business, e soprattutto confonde concetti, mescolandoli assieme, che non andrebbero confusi. Vediamo il perché.
La chiamano economia creativa. Ne scrivono tutti, con immensa confusione. Danno alla creatività una valenza culturale, alla cultura una valenza di intrattenimento, all’intrattenimento una valenza economica. Poi mescolano nel pentolone una serie di altre cose, che centrano e non centrano con il nostro discorso. Internet, ormai termine che dice tutto ma soprattutto non dice niente. Il gap digitale che abbiamo nei confronti degli altri paesi. Il Pil dell’economia creativa e culturale. Sommano a queste cose dati che non sono accostabili: nell’industria creativa mettono il Made in Italy, che fino a qualche anno fa era industria manufatturiera. Nell’economia creativa aggiungono vinificatori, pastai, slow food, cuochi di cucina progressive, relais & chateau, meditazioni yoga, turismi enogastronomici, mistiche vegetariane, persino la green economy. Tutto vero e tutto possibile. Ma a questo poi aggiungono l’editoria, i lettori forti, i lettori deboli, i siti archeologici, le mostre nazionalpopolari del complesso del Vittoriano a Roma, i festival del cinema, i premi letterari. E naturalmente le application di Apple. Le application di Android, i canali digitali, i televisori multimediali, i tablet che ti connettono, e le tasse che ti sconnettono. Risultato. Un pandemonio.
E allora cominciamo con il dire qualcosa che ai fautori dello slow mind, del tempo libero che si trasforma in un affare, non piacerà molto. Non esiste una economia creativa. Perché le due cose, economia e creatività, non sono compatibili. Ma soprattutto non esiste una forma di creatività che sia ottimizzabile per il mondo delle imprese. Un grande psicoanalista indiano, naturalizzato inglese, Masud Khan, in un suo fondamentale saggio intitolato Lo spazio privato del sé, paragonava la creatività a un «campo coltivato a maggese». Ovvero confinava, o esaltava, a seconda dei punti di vista, la creatività a una sfera separata, priva di regole, quasi abbandonata, che dava frutti solo se veniva lasciata riposare. Le fucine di idee, le factories di cui si parla sempre di più esistono sempre a posteriori: ovvero lo sai dopo che erano fucine di idee. Andy Wharol non lo sapeva di certo, e non pensavano di essere una fucina di idee i ragazzi di via Panisperna. Lavoravano a un progetto e basta.
Aver deciso che tutto questo può prendere corpo, consistenza e generare utili, lavoro, occupazione, e migliorare al contempo le qualità della nostra vita è una illusione nel migliore dei casi, nel peggiore invece un paradigma di pensiero che appartiene alla produzione dei tondini di acciaio più che all’atelier di Salvador Dalì, o alla casa di Peggy Guggheneim.
Se ora vi dico questo, è perché ho precisa idea di quello che potrebbe accadere rendendo la cultura un progetto serio per questo paese. E se in questo esatto momento tutti voi state pensando che io mi contraddico, vi consiglio di non dare un giudizio affrettato. La cultura non è un affare. La cultura è una condizione indispensabile per rendere questo paese moderno, e un paese moderno è un affare. A patto che sia cultura e non business, a patto che abbia un tempo di lungo periodo, e non di breve, se non brevissimo periodo, e soprattutto che non si trasformi in un fine. E allora guardate questa slide per favore.
Economia culturale e creativa
2003: 2,3% del Pil
2004: 9,3% del Pil
2010: 5.0% del Pil
La slide vi confonderà le idee, il dato del 2004 è molto alto rispetto a quello dell’anno prima e a quello di 6 anni dopo. Ma in quel dato c’è tutto il Made in Italy. Mentre il terzo dato, che vuol dire anche il 5,7 per cento dell’occupazione nazionale, è di fonte diversa, non contempla il Made in Italy, ma forse include l’eno-gastronomico. Questo per dire che i dati sulla cultura, e la cultura intesa come possibile volano dell’economia del paese sono quanto di più indeterminato e impreciso si possa immaginare. Ma perché?
La risposta è di una semplicità disarmante: perché nessuno sa di cosa stiamo parlando. Visto che non esiste una coerenza e un equilibrio tra chi ci mette anche il turismo, e ça va sans dire, il turismo culturale, e dice che il nostro paese diventerà ricco con il suo patrimonio artistico e ambientale, e chi si occupa del valore vero e proprio di questo patrimonio artistico. Ovvero: gli intellettuali, chiamiamoli così. Tra chi vuole fare affari con i merchandising dei musei e chi immagina musei che emozionino e colpiscano i visitatori c’è una forbice incolmabile. Un paradigma impossibile, che nessuno oggi è in grado di colmare. Al punto che neppure nella definizione se ne viene a capo. Ora guardate questa slide.
Occupati nelle case editrici
Spagna: 71.000
Italia: 89.000
Francia: 145.000
Germania: 413.000
In Germania le persone che lavorano in case editrici, a tutti i livelli sono quasi cinque volte rispetto all’Italia. Voi direte: per forza, in Italia si legge molto meno rispetto alla Germania, il mercato editoriale è più piccolo. E dunque è un dato del tutto ovvio. Ma allora guardate questa slide sui lettori italiani, riferita al 2011. È un dato Istat.
Lettori in Italia
2010: 46,8%
2011: 45,3%
Significa 700 mila lettori in meno. Colpa della crisi, certo. Colpa della debolezza dei lettori in Italia? Mica tanto. I lettori forti sono calati, e in modo più deciso. Guardate questa slide. Lettori forti in Italia (più di 12 libri l’anno) 2010: 15,1% 2011: 13,8% Ci ha catapultato, con questo dato al 7% di spesa per le famiglie sui consumi culturali. Al livello di Estonia, Lituania, Bulgaria e Romania. E allora? Il tesoro culturale su cui stiamo seduti, che dovremmo valorizzare, chi lo estrae e chi lo riconosce? Non temete. A questo punto arriverà qualcuno a dire che c’è internet, parola misteriosa che comprende: computer, modem, banda larga, browser, reti per telefonini, tablet, televisori di ultime generazioni, presenza nei social network, web journalism, e quant’altro. Cosa è internet lo sanno tutti e nessuno lo sa. Ma che rapporto c’è tra un mezzo di trasmissione di dati e informazioni e valorizzazione ma anche commercializzazione del patrimonio culturale non si riesce bene a capire. E non si riesce bene a capire dove la creatività si unisce al cosiddetto internet. Mi permetterete questa ironia, ma ogni volta che sento parlare di internet mi viene alla mente la presa della corrente. Il lume si accende perché ho la corrente, se accendo il lume posso leggere un libro. Se poi leggo un libro di Fabio Volo anziché di Tolstoj fa una certa differenza.
Modernità e creatività, e dunque cultura passano da internet. Ed è vero. Al buio i libri sono tutti uguali. La metafora della lampadina è l’unica possibile. E anche in questo siamo indietro. Internet vale il 2,5% del Pil italiano, contro, per fare un solo esempio, il 7% della Gran Bretagna. Mancano le infrastrutture, manca una cultura digitale. Anche quella. Come fare?
Va inventato tutto. L’economia creativa deve avere alle spalle una cultura creativa. Deve credere e progettare l’innovazione, deve portarci nel futuro. Ma in Italia le persone che lavorano in ambito culturale sono 1,1% contro il 2,2% della Germania. Solo che in Italia abbiamo più di 40 siti protetti dell’Unesco, e i tedeschi no. Apprendo inoltre dal Sole 24 Ore che tra il 2007 e il 2011 l’Italia ha ricevuto aiuti dal Programma Culturale Europeo per 22,8 milioni di euro, ma l’anno scorso pur avendo presentato alla Commissione il più alto numero di domande, il paese ha avuto un numero basso di risposte positive, con un tasso di successo di appena il 17%. Dennis Abbot, protavoce dell’esecutivo comunitario, nota che la selezione tra i diversi progetti è severa e che non sempre le domande rispettano i criteri imposti dalla Commissione.
Non va bene, si potrebbe dire. Certo che non va bene, ma la vera domanda è: perché non va bene? E perché non va bene che l’export culturale italiano è dello 0,3% con un calo del 3,3% annuo tra il 2004 e il 2009, mentre la Francia in cinque anni è aumentata del 3,5% annuo. E i soliti tedeschi hanno esportato cultura per 4,2 miliardi di euro. Non va bene per una serie di motivi storici e culturali. Il primo è un modo lagnoso e spesso parassitario della cultura in Italia. La cultura italiana è alla continua ricerca di contributi, di finanziamenti, di aiuti e di aiutini. Dallo Stato certo, ma anche dai privati. L’idea rinascimentale del mecenatismo diffuso è l’idea centrale che regola ogni rapporto di forza e di potere e ogni senso della realtà di quella che potremmo chiamare l’industria culturale italiana. C’è poco da fare. Non vendiamo più format televisivi all’estero, non promuoviamo i nostri musei e la nostra arte. E mentre il Louvre apre una sede ad Abu Dhabi da noi stiamo ancora discutendo dell’industria creativa.
Cosa è accaduto? È accaduto un qualcosa che andava previsto. E che può essere spiegato con una recente decisione del Presidente Barack Obama: quella di intensificare l’insegnamento di materie scientifiche, e per prima cosa della matematica nella scuole primarie americane. Per diminuire il gap con paesi molto dotati come l’India e la Cina. Si comincia dai bambini, come sempre. E si coltiva a maggese, direbbe Masud Khan, si lascia fare e si aspettano i frutti. Non si può inneggiare all’industria culturale, alle potenzialità della cultura e poi fare in modo che cultura e conoscenza rimangano qualcosa di secondario, se non fastidioso, nella cultura manageriale italiana. Sono tutti ammirati del fatto che Apple abbia un fatturato superiore al Pil di un paese sovrano come il Belgio, e una liquidità impressionante. Qualsiasi imprenditore prenderebbe a modello Apple per la sua azienda. Ma Apple è un’industria creativa. Ed è solo per questo che funziona. E non funziona solo Apple. Il rapporto annuale sulle creative industries dice che rappresentano il 6,4% del Pil degli Stati Uniti, 10 milioni di lavoratori, 700 mila imprese solo nel settore delle arti. Le proprietà intellettuali valgono qualcosa come 5.500 miliardi di dollari. I salari sono più alti fino al 27% rispetto alle altre aziende.
Ma accade questo perché la cultura non è soltanto qualcosa da tutelare, tenere immobile e proteggere come fosse una statua del Louvre. Ma le industrie creative non sono un nuovo modo inaspettato per fare profitto, visto che abbiamo sempre più tempo libero, ma vanno pensate in termini di investimento per il futuro di un paese e la cultura di un paese.
Non lo abbiamo fatto. Lo ripeto: da noi, e sia chiaro, non è stato fatto: non si fa oggi, e per ora niente ci porta a pensare che potrebbe essere fatto nel futuro. Obama aumenta gli insegnamenti tra i bambini, noi spostiamo modelli obsoleti, e culturalmente perdenti, in una dimensione dove la modernità li fa apparire ancora più inadeguati. Non è questione di fatturati e neppure di ricchezze. Non si tratta di cavalcare il digitale, la cultura, l’intrattenimento televisivo o intellettuale per ricavare profitti. La cultura non è una gallina dalle uova d’oro. Le uova d’oro ci sono, ma le uova di un’aquila, non quelle di una gallina. Ed è chiaro che la differenza non è da poco.
Bisogna insegnare alle nuove generazioni a scalare le cime, là dove osano le aquile piuttosto che a razzolare nei pollai. Sapendo che si tratta di scommesse difficili. Bisogna partire da zero. Ricominciare. Ci vorranno anni, ma questo non significa che non sia necessario e obbligatorio farlo. La cultura è una ricchezza complessa, chiede di essere riconosciuta, chiede una cura particolare: fatta di tanta consuetudine, di abitudine, deve arrivare al dna di varie generazioni, e rimanerci, come un patrimonio genetico. Come la matematica dei bambini americani che dovranno sfidare nei prossimi decenni quelli indiani e quelli cinesi. Noi per ora dobbiamo cominciare a sfidare noi stessi. La sfida di uscire dai luoghi comuni che vogliono la cultura una scommessa per far soldi, o un rifugio perdente per quanto rispettabile per sfaccendati e poeti svagati. Nessuna delle due cose. Ma sapremo aspettare che anche in questo le cose cambino. Ormai è necessario quasi quanto la riforma del mercato del lavoro o delle pensioni.