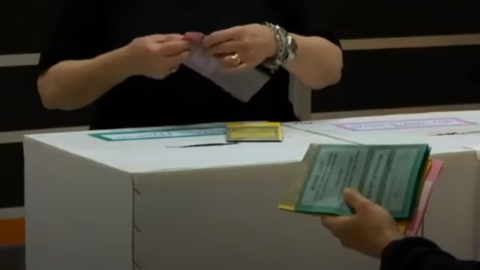“Il Recovery Fund alle Regioni” hanno titolato molti giornali alcune settimane addietro per dare conto della posizione espressa da Stefano Bonaccini nel suo ruolo di presidente della Conferenza delle Regioni italiane. Che così argomentava: “Come Regioni chiederemo delle quote per avere una gestione diretta dei fondi. Servirebbe per essere più veloci”. Si sta parlando degli ormai famosi 209 miliardi di euro assegnati dal Consiglio europeo del 17-21 luglio all’Italia, di cui 82 a fondo perduto e 127 di prestiti.
Marcello Messori, in una sua bella analisi, ha definito “storico” questo accordo europeo per una prima fondamentale ragione: perché – citiamo – “l’intesa potrebbe essere ricordata in futuro come il primo passo (anche se ancora abbozzato) verso una Unione fiscale europea” (22 luglio). Egli ha poi sottolineato, per il nostro Paese, che “le sfide per l’Italia” sono “senza precedenti”.
In tale più ampio contesto, cercherò – in questa sede – di sviluppare la proposta avanzata dal presidente Bonaccini, riprendendo alcune considerazioni che ho originariamente svolto sull’Emilia-Romagna (si veda l’editoriale “L’esempio tedesco del Baden”, in Corriere di Bologna, 6 agosto), nella consapevolezza che almeno una parte di esse possa riguardare l’Italia delle regioni nel suo insieme.
Qui e ora, dunque, la domanda diviene: è bene che vi sia un ruolo per le Regioni nella gestione del Recovery Fund? E se sì, per fare cosa? Per tentare una risposta è necessario fare un passo indietro; anzi due.
Primo: dalle Conclusioni del Consiglio apprendiamo che nel “Next Generation EU” (questo il nome ufficiale del fondo da 750 miliardi di euro) lo strumento più importante è il “Dispositivo per la ripresa e la resilienza”; ne consegue che gli Stati membri devono preparare dei “Piani nazionali” in cui è definito il programma di riforme e investimenti per il periodo 2021-2023. A loro volta, gli investimenti devono rafforzare “il potenziale di crescita e di creazione di posti di lavoro”, in primis seguendo le due direttrici strategiche della sostenibilità ambientale e del digitale.
Ma vi è un secondo passo indietro da compiere: l’Emilia-Romagna, per restare al nostro primo esempio, può vantare una lunga e consolidata tradizione di efficiente utilizzo dei fondi comunitari (e basti pensare al Fondo sociale europeo). Altre regioni, in specie del Centro-Nord, si muovono lungo la stessa direzione, mentre più problematica è la situazione nelle regioni del Mezzogiorno. Se il Governo darà seguito alla richiesta proveniente dalle Regioni italiane – com’è auspicabile in un Paese dove vitale è il ruolo delle comunità regionali e di tutte le autonomie territoriali, come ha posto in rilievo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo incontro con i Presidente di Regione (Quirinale, 4 agosto) -, per tutte non si tratterà di una novità assoluta. Ma è bene tenere a mente che la portata di questa sfida è, per le nostre Regioni, decisamente diversa da tutte quelle del passato.
La domanda fondamentale sull’utilizzo su base regionale di parte del Recovery Fund resta la seguente: per fare cosa? Fra le molteplici tipologie di investimenti (materiali e immateriali) meritevoli di attenzione, vi sono certamente gli investimenti in conoscenza (R&S, capitale umano, information technology), con particolare riguardo ai due network che hanno grandemente contribuito a costruire l’eccellenza dell’industria tedesca: le Fachhochschule (University of Applied Science) per la formazione tecnica; il Fraunhofer-Gesellschaft per la ricerca applicata. Sulla coerenza di queste istituzioni educative e di ricerca con un’economia a forte vocazione manifatturiera – come quella italiana – esiste da tempo un ampio consenso sia fra gli studiosi, sia fra gli imprenditori.
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) che sono stati lanciati a livello sperimentale negli ultimi anni, grazie all’istituzione di Fondazioni ad hoc pubblico-private, sono ormai una realtà in molte regioni, a partire da quelle del nuovo Triangolo industriale ma non solo in queste, come ha mostrato il Corriere della Sera parlando in primis della Fondazione Meccatronica Lombardia presieduta da Monica Poggio (“Occupazione, la formula ITS: subito al lavoro l’83% dei ragazzi”, 13 agosto). D’altro canto, in nessuna regione italiana opera qualcosa di paragonabile agli istituti del Fraunhofer. Il momento appare propizio – fors’anche irripetibile – per il definitivo salto di qualità sotto entrambi i profili.
Una comparazione fra le nostre principali regioni manifatturiere e il Baden-Württemberg sul piano degli investimenti in R&S ci dice della distanza che ancora ci separa dal Land tedesco: il rapporto R&S/Pil oscilla, a seconda dei casi, fra l’1,3% e il 2% da noi, mentre balza al 5% da loro. La presenza su quel territorio sia delle Università delle Scienze Applicate, sia del Fraunhofer è impressionante. Dai documenti ufficiali apprendiamo che vi sono più di venti università di questo tipo (che offrono un percorso di istruzione terziaria a circa un terzo degli studenti universitari iscritti) e 17 organizzazioni riconducibili al Fraunhofer (di cui ben 13 sono Istituti).
Ma al di là della loro numerosità, vi sono due altre caratteristiche rilevanti. Anzitutto, entrambe le Istituzioni, nel loro campo d’azione, fanno parte di un sistema dove vi è una razionale divisione dei compiti con altre Istituzioni come, per esempio, nell’alta formazione con le “Research Universities” e nella ricerca industriale con l’”Innovation Alliance Baden-Württemberg (innBW)”. E’ poi la missione di queste istituzioni a proiettare la loro attività verso il domani. I soggetti di studio delle Università delle Scienze Applicate – nate negli anni Settanta – si sono venuti evolvendo e comprendono oggi, accanto alle più tradizionali discipline tecnico-ingegneristiche, anche computer science, matematica e scienze naturali. Dal canto loro, gli Istituti del Fraunhofer – fondato nel 1949 – operanti nel Baden-Württemberg coprono molte delle traiettorie tecnologiche più promettenti: la fisica in molte delle sue applicazioni (pensiamo ai laser e ai sensori), le biotecnologie, l’energia solare, e l’elenco è molto più lungo.
Insomma, il “capitalismo renano” si conferma ancora una volta una valida fonte d’ispirazione. Ora, non si tratta di replicare tout court alcune delle sue principali istituzioni educative e di ricerca (quelle qui menzionate), bensì di implementarle con gli adattamenti suggeriti sia dal nostro diverso assetto istituzionale (non siamo uno Stato federale come la Germania), sia dalle più brillanti esperienze maturate sui molti territori in cui è dislocata la manifattura italiana.
Il tutto senza dimenticare che questo gigantesco programma “alla tedesca” sugli investimenti in conoscenza (Fachhochschule e Fraunhofer) dovrebbe essere parte, a sua volta, di un più generale piano di politica industriale. Quella politica industriale “nuova” o “moderna” di impronta europea che, per restare in Germania, è saldamente nelle mani del Governo federale di Berlino e ha lo sguardo rivolto al 2030. E quella politica industriale che, invece, in Italia manca da troppi anni, per non dire decenni, e che – come su queste colonne ho già avuto modo di scrivere – è giunto il momento di riportare in cima nell’agenda di policy del Paese.