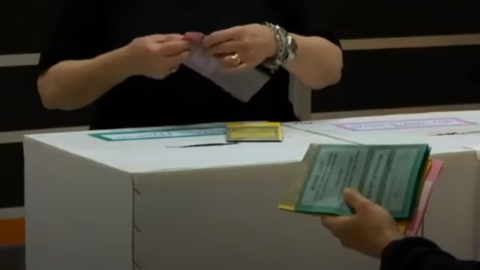Era prevedibile che la vendita di un’icona della moda italiana come Valentino all’emiro del Qatar, proprio nelle stesse ore in cui il suo Paris Saint Germain sta portando via a peso d’oro due fuoriclasse del calcio come Ibrahimovic e Thiago Silva dal Milan di Silvio Berlusconi, scatenasse sussulti di italianità e rinfocolasse il patriottismo economico. E a poco vale ricordare che per l’80% Valentino era già da tempo in mano al fondo inglese Permira e solo per il 20% alla famiglia Marzotto. Ma la paura fa novanta e, senza rammentare i precedenti di Safilo e di Ducati, l’allarme si era diffuso anche qualche giorno fa quando il fondo Pamplona del russo-americano Alexander Knaster aveva annunciato di avere in portafoglio il 5% di Unicredit e aveva destato stupore apprendere da un’indagine della Consob che un terzo delle società quotate alla Borsa di Milano rivelano la presenza nel capitale di fondi sovrani del Paesi emergenti.
L’idea che l’Italia sia diventata terra di conquista e che oggi – un po’ per la sottovalutazione dei titoli di Borsa e un po’ per gli effetti perversi della crisi – i gioielli del Belpaese si possano acquistare a prezzi di saldo ha un suo fondamento. Ma non sempre ciò che è reale è razionale e la paura dei barbari alle porte ha più un sapore ancestrale che una logica economica. Tra il disappunto per il passaggio di Valentino ai reali del Qatar e l’assenza di investitori esteri in Italia che ogni asta di Bot o Btp mette impietosamente a nudo c’è qualcosa che non quadra. E stupisce che un’Authority come la Consob, che dovrebbe avere a cuore l’allargamento dell’asfittico mercato borsistico italiano, gridi al lupo per la crescente presenza nel capitale delle nostre società di fondi sovrani. Questi fondi rispondono per lo più all’azionista Stato di Paesi a debole o inesistente democrazia, ma spesso sono solo sleeping partner a caccia di alti rendimenti sui mercati finanziari occidentali per diversificare gli investimenti e trovare sbocchi ai pingui profitti derivanti dal petrolio o dalle loro materie prime.
Proprio la fuga dall’Italia degli investitori stranieri e l’enorme difficoltà di attrarre capitali esteri dovrebbero indurre ad archiviare paradigmi di vecchio stampo e a sviluppare riflessioni su ciò che realmente conta per il nostro Paese e per il suo problematico rilancio. Non per caso nei giorni scorsi Mario Monti è corso al meeting di Allen&Co a Sun Valley negli Usa per convincere gli investitori americani – c’erano Bill Gates, Murdoch, Buffet, Bloomberg e tanti altri esponenti di spicco del gotha finanziario – a dare fiducia all’Italia che cambia e a investire nel nostro Paese. Non sarà difendendo l’italianità e coltivando a tutti i costi l’ossessione del controllo di tutte le nostre aziende e di tutte le nostre società che modernizzeremo il nostro capitalismo relazionale e che ritroveremo la via dello sviluppo. Il caso del Nuovo Pignone, che dai tempi del mitico sindaco di Firenze La Pira aveva imboccato la via del declino, ma che ha ritrovato smalto quando l’Eni l’ha venduta agli americani della General Electric fa meditare. Certo, sull’altro piatto della bilancia, le pratiche disinvolte di un gruppo un po’ opaco come quello dei francesi di Lactalis sul tesoretto di Parmalat suscitano amarezza e portano a qualche conclusione. Nel capitalismo contemporaneo non è la proprietà che fa la differenza e che assicura il futuro delle società (che vuol dire non solo dividendi per gli azionisti ma posti di lavoro e investimenti) bensì la qualità della gestione e del management. Ben vengano dunque nuovi investitori e nuovi fondi sovrani nel nostro Paese perché questo può voler dire capitali, fiducia e sviluppo per le nostre aziende, per i loro soci e per i loro dipendenti. Ma a certe condizioni. Come ricordava spesso il compianto Tommaso Padoa-Schioppa, il patriottismo economico non è affatto un concetto desueto anche ai tempi della globalizzazione. E’ giusto, in condizioni di reciprocità, aprire le porte del nostro mercato ma ci sono alcuni beni che un Paese moderno deve saper difendere nel rispetto delle regole del gioco e del mercato. Può dispiacere, ma Valentino si può vendere agli investitori stranieri senza che questo pregiudichi lo sviluppo dell’economia italiana ma l’Eni o la Finmeccanica o le Generali assolutamente no.
La recentissima indagine annuale di R&S Mediobanca sulle multinazionali nel mondo fa rabbrividire e fotografa una realtà che spesso ignoriamo e che rivela la nostra l’incapacità – che non è solo imprenditoriale ma è del sistema Paese – di far crescere e coltivare le grandi imprese anche da noi: le multinazionali italiane sono solo 19 di cui tre con sede nel Benelux e solo due (Eni ed Exor) collocate nelle top 20. E’ inutile che poi piangiamo sulla miseria delle risorse destinate alla ricerca e allo sviluppo: senza grandi imprese non si fa R&S ma senza R&S non si innova e non si cresce.
Ecco perché non tutto si può vendere ed ecco perché il patriottismo economico e la difesa dell’italianità sono talvolta giustificati. Quando? Quando sono in gioco le sorti di imprese che hanno un forte impatto sullo sviluppo dell’economia del Paese e che non sono replicabili nè sostituibili. Il numero delle imprese italiane davvero strategiche e come tali da difendere dagli appetiti stranieri è perciò molto ristretto ma è determinante e riguarda:
1) le grandi reti infrastrutturali del gas, dell’elettricità, delle telecomunicazioni, delle ferrovie, delle autostrade, dell’acqua e le società che le gestiscono (dall’Eni a Terna, dalla Snam a Enel e a Telecom Italia e via dicendo);
2) le società che gestiscono i flussi finanziari e il risparmio degli italiani come le due grandi banche (Intesasanpaolo e Unicredit) ma anche Mediobanca e Generali (che custodiscono pacchetti azionari delle aziende chiave e possono mobilitare grandi investimenti);
3) infine come intoccabili, perché parte essenziale del patrimonio imprenditoriale nazionale, vanno considerate la Fiat e la Finmeccanica: la prima perché è la maggiore industria italiana ed è ancora l’industria simbolo del Paese e la seconda perché rappresenta la maggior industria della difesa.
In totale sono, dunque, poco più di una decina le aziende che l’Italia ha il dovere di coltivare e difendere nel rispetto delle regole del mercato e in una logica di sistema Paese. Qui lo straniero non deve passare, salvo che per quote di minoranza. Per il resto porte aperte al mercato e via libera a tutte le privatizzazioni e a tutte le liberalizzazioni che possono portare quella concorrenza e quello sviluppo di cui abbiamo bisogno come il pane.