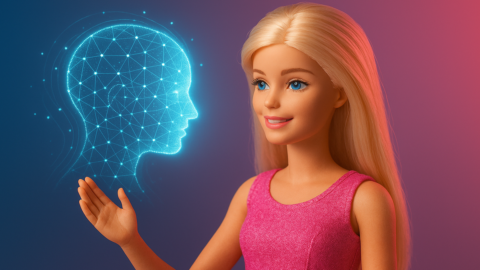Nel 2000 erano 360 milioni le persone collegate alla rete internet. Dopo poco meno di 16 anni sono oltre 3 miliardi . Ciò significa che la metà della popolazione mondiale ha un accesso ad internet.
In un lasso di tempo brevissimo il mondo è cambiato ad una velocità tale, da rendere enorme la distanza anche tra generazioni vicine. La rete, insieme alle innovazioni e alle tecnologie ad essa connesse, sta ridisegnando, con una progressione esponenziale, i paradigmi che regolano la società: il nostro modo di stare insieme, comunicare, produrre, divertirci, lavorare, imparare.
L’Italia è immersa in questo cambiamento ma si trova a fare i conti con una popolazione sempre più vecchia, perennemente schiacciata sul passato, agitata da rissosità ataviche. E tuttavia qualche buona carta da giocare ce l’ha. Ne parliamo con Francesco Beraldi.
Come fa un business giovane a prendere dimora in un paese vecchio? Sono in tanti a chiederselo di fronte all’avanzata della rivoluzione digitale. Il fatto forse più strabiliante è che nemmeno i protagonisti – gli innovatori che parlano la nuova lingua del 2.0 – hanno la risposta in tasca. “Siamo un paese che non può contare su grandi capitali, in declino sotto il profilo demografico e culturale e quindi allergico al rischio”. Impietosa ma non disperata, l’analisi che ci consegna Francesco Beraldi, presidente di Alkemy tech, società di consulenza digitale e primo enabler in Italia, non nasconde sotto il belletto della retorica le difficoltà che incontra un paese schiacciato sul passato ad accettare un cambiamento che, prima che economico, è culturale.
Persino nei territori a più forte vocazione imprenditoriale (“penso alla Lombardia”) emerge una certa stanchezza, una stanchezza rintracciabile anche nel comportamento di quegli imprenditori che decidono di fare una puntata sul digitale ma col braccio un po’ corto – per dirla come la dicono a Roma, dove Beraldi vive e dove lo abbiamo incontrato – gettando sul tavolo poche fiches, magari perché “nei settori di investimento tradizionali i margini si sono talmente ridotti che, seppur con riluttanza, si va alla ricerca di un ritorno altrove”. Ma, appunto, questo “altrove” fatica ancora a materializzarsi. Motivo per cui, in molti casi, rischia di restare confinato nell’immaginario anziché incarnarsi nella dimensione dell’impresa.
Perché si investe nel digitale in Italia? “Mah, per molti è anche una questione di vanità”. Esserci per apparire, non per creare valore; mentalità da utente medio di Facebook, pure un po’ agé, non da imprenditori. “Vale anche per Facebook: insieme al bisogno di comunicare e condividere gusti, idee, esperienze, la vanità recita una parte importante: da questo complesso mix di elementi può nascere un impero”. Purché non ci si dimentichi che gli imperi poggiano su solide fondamenta, e che queste fondamenta – nel caso di Zuckerberg e dei suoi compagni di banco della Silicon Valley – sono impastate con la malta dei dollari. Miliardi di dollari. Dello stesso materiale è fatta pure l’intelaiatura, la cui leggerezza è solo apparente, un’illusione ottica indotta dal carattere fluttuante del web, dei nuovi signori della sharing economy, su tutti AirBnb e Uber.
Ma a ben vedere non sono i capitali a fare la differenza (“anzi, all’inizio viziano”) bensì le persone. Beraldi è un anti materialista, se così si può dire. Non sarebbe andato d’accordo con Ricardo e Marx: solo l’idea che il valore di un bene sia una derivata dalle quantità di lavoro che incorpora lo fa rabbrividire. Invece ha un debole per Schumpeter, che nella nostra conversazione cita spesso. Gli piace l’idea dell’economia come relazione, che la scuola austriaca vede iscritta nel mercato, nella logica dello scambio così come nella competizione (cum- petere significa cercare insieme, no?), e, ovviamente, considera la “distruzione creatrice” il manifesto dell’impresa e la bussola di ogni innovatore. Perciò lo spaventa la mancanza di cultura d’impresa che vede in certi “startupper” di casa nostra, giovani che non di rado “hanno idee valide” ma che ancora non maneggiano abbastanza i ferri del mestiere. Anche se fortunatamente non è questa la regola. Esempi positivi? Beh, guardate un pò Davide Dattoli, 25 anni, fondatore di Talent Garden, la maggiore rete di coworking italiana, che ora è sbarcato anche a Roma.
E’ anche vero che l’imprenditore , se non ha una visione all’altezza dei tempi, se dimentica la sua funzione di catalizzatore dell’innovazione (e qui ritorna Schumpeter) , finisce per fuggire dal rischio. Il che è vero in generale ma lo è ancor più dinanzi ad una “rivoluzione dirompente come quella che stiamo vivendo”. Nemmeno questa è la regola, ma di esempi – negativi stavolta – il panorama italiano non è certo avaro: basta pensare alle difficoltà di comprensione del capitalismo familiare ed al suo rifugiarsi nella rendita anziché sfidare a viso aperto il mercato.
Il timore di Beraldi è che il nostro sistema imprenditoriale si polarizzi tra questi due estremi, tra i quali vede avanzare un’incomunicabilità che può trasformarsi in una “frattura” pericolosissima. Sarà perché in presenza di un ‘innovazione che tocca il modo stesso di interagire dell’uomo si finisce per subirlo e “si è sempre un passo indietro nella nostra visione del mondo”, come diceva Marshall McLuhan, ma il disorientamento che si respira nell’atmosfera rarefatta del capitalismo italiano corre il rischio di degenerare in “crisi di rigetto”. Sono passati tanti anni da quando Vittorio Valletta enunciava l’intenzione di “estirpare il seme dell’elettronica”, eppure a volte pare di essere ancora lì, all’epoca in cui Olivetti sgomitava per affermare un “modello diverso, comunitario, di gestione del lavoro”, qualcosa che poi abbiamo visto tornare sotto altri cieli, per esempio in Google con Larry Page. Da Ivrea a Mountain View, un filo esile ma resistente tiene insieme storie diverse dentro un universo di valori che si struttura attorno alla persona, alla sua creatività ed al valore della collaborazione. Anche Beraldi è passato dall’Olivetti e, benché “l’azienda fosse in stato terminale”, ne è rimasto folgorato. Poi, dopo una breve esperienza in IBM (“lì quelli come me facevano solo i venditori”), l’approdo in TAS, gruppo leader in Italia nei software per la monetica, i sistemi di pagamento e i mercati finanziari, dove “ho imparato cosa significa fare impresa”.
Nel 1998 nasce internet e se ne innamora, capisce che il futuro è l’open source – chiama Microsoft “la cattedrale”, una sorta di monolite contrapposto al “paesaggio liquido” dei bazar del fare software che inizia a proporsi – e decide di tentare la sorte. Fonda la sua azienda, Orangee: diventa uno startupper, anche se ante litteram. “Mi sono detto: chiedo ai clienti di scommettere sull’open source” anziché svenarsi per un software proprietario e “in questo modo assicuro un futuro all’azienda ed ai ragazzi”. Invece che sulla standardizzazione, investe sulla “customizzazione” del dei software Open source creando la sua “comunità di artigiani del web”, l’unica forma di organizzazione del lavoro che calza davvero sul modello di produzione orizzontale del software. E’ un’immagine, quella della “comunità di artigiani”, che la memoria ha archiviato in un vecchio file, l’immagine della strada principale del suo paese, Caloveto, piccolo borgo ionico del cosentino, dove le botteghe si allineavano una dietro l’altra: una “comunità del fare” che lasciava germinare l’innovazione in modo spontaneo.
Dopo aver schivato qualche rovescio di fortuna, di quelli che in Italia portano alla tomba tante imprese (per capirsi: clienti che non pagano) , e dopo un bel po’ di notti trascorse insonni a fare e rifare i conti, Orangee entra a far parte del gruppo Finmeccanica “Una PMI sana con 100 dipendenti, 7 milioni di cassa e 8 di fatturato”. Siccome non vuole finire i suoi giorni da rentier, abbraccia la TSC (Talent Solutions for Cloud) con il suo lab innovation creato da Alessandra Spada (secondo MacPherson tra le 10 donne più influenti nel digitale in Italia, per farne una delle prime società leader e precursore in Italia nella digital trasformation. Nel 2015 entra nel gruppo di Alkemy, di cui diviene principale azionista insieme alla Spada. Nel frattempo continua a seguire un’altra delle sue creature, O2e, con cui partecipa e crea reti con imprese innovative, da Superpartes, il campus startup di Brescia, spinoff universitari come DtoK fino ai Tag e a tante altre secondo il modello Open innovation.
———-
L’EVENTO DEL 23 GIUGNO – “L’arte di fare Impresa, l’impresa di fare Arte”
Sala Auditorium dell’Ara Pacis (ingresso via Ripetta)
Programma dell’evento
18.30 Cocktail di benvenuto sulla terrazza dell’Ara Pacis
19.30 Apertura dell’evento con Gianfausto Ferrari e Francesco Beraldi
19.45 Viaggio con la musica e l’impresa dal Contrappunto al Jazz a cura del Maestro Nicola Scardicchio con:
• Gianfausto Ferrari – Presidente Superpartes
• Luciano Belviso – Presidente Blackshape
• Francesco Beraldi – Presidente Alkemy Tech
• Davide Dattoli – Presidente TAG