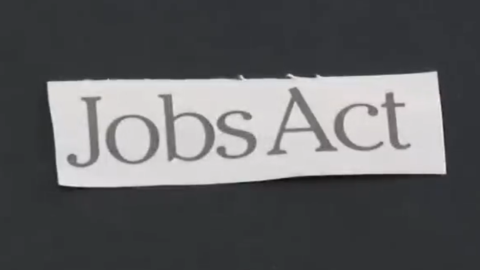Un’opzione importante
Negli ultimi dieci anni il dibattito sui beni comuni si è andato sempre più affievolendo. Colpa della radicalizzazione politica ed ideologica che ha investito la conversazione pubblica in tutto il mondo. Eppure, siamo in un’economia sempre più polifonica dove convivono e operano privato, pubblico, terzo settore, cooperative e le nuove forme economiche della rete. In questo tipo di economia i beni comuni possono essere un’opzione importante. Anzi possono essere un’opzione risolutiva nella gestione di risorse strategiche per il futuro del pianeta.
Sono anche un’opzione importante a livello politico perché i beni comuni, proprio per la loro natura collettiva, avvicinano i cittadini alle istituzioni e li coinvolgono direttamente in azioni di pubblico interesse. In tempi di scollamento tra istituzioni e società civile, il tipo di associazionismo prodotto dalla condivisione di responsabilità di un bene pubblico sarebbe una grandissima azione di comunione civica.
Il dibattito sui beni comuni riguarda proprio il governo delle grandi risorse naturali: le foreste, gli oceani, l’acqua, il cielo, lo spazio. Risorse che rischiano la spoliazione, se non cambia il modo in cui sono oggi amministrate in ambito pubblico e non solo pubblico.
Facciamo il punto
Due recenti libri editi da goWare hanno cercato di fare il punto sugli studi e il dibattito intorno ai commons. Il primo, Beni comuni diversità, sostenibilità, governance. Scritti di Elinor Ostrom, offre alcune riflessione del premio Nobel dell’economia. L’economista dell’Università dell’Indiana ha dato “un contributo decisivo all’analisi della governance in economia, in particolare del bene comune”. Così recita la motivazione del Nobel alla Ostrom.
Il libro contiene anche il saggio di Garret Harding sulla tragedia dei beni comuni, citato nell’articolo che riportiamo sotto. Un saggio importante che ha un po’ cristallizzato l’opinione sulla scarsa sostenibilità di questa forma di possesso collettivo. Un’opinione che è diventata mainstream.
Il secondo libro è Omnia sunt communes. Il dibattito internazionale su commons e beni comuni. Esso ha lo scopo di offrire una panoramica delle principali posizioni teoriche e disciplinari nel dibattito internazionale.
Il lettore vi può trovare una dozzina di saggi, spesso inediti in lingua italiana di autori che studiano il fenomeno dei commons nei differenti campi. Si tratta di David Bollier, Massimo de Angelis, Silvia Federici, Garrett Hardin, Michael Hardt, Naomi Klein, Lawrence Lessig, Peter Linebaugh, Donald M. Nonini, Elinor Ostrom e Vandana Shivaan. Questi contributi specifici aiutano quindi a orientarsi all’interno di una tematica che inizia a interessare molti campi di attività del vivere comune.
Si torna a parlare autorevolmente di beni comuni
A riportare a galla il discorso smarrito sui beni comuni e a riproporlo con una certa forza è una fonte abbastanza inaspettata, ma indubbiamente autorevole e ascoltata. Si tratta di uno dei maggiori think-tank del capitalismo moderno, il magazine londinese “The Economist”. La prestigiosa testata è da tempo seriamente preoccupata dalla crisi in cui versa il sistema capitalistico. Una crisi alla quale il magazine londinese, in genere piuttosto assertivo, non riesce a delineare uno sbocco plausibile se non rifondandolo dalle radici. Un percorso che spaventa i suoi stessi sostenitori.
Bene in questa possibile rifondazione ci sarà un ruolo importante per i beni comuni, afferma l’“Economist”. Succede che l’“Economist” ed Elizabeth Warren si stiano congiungendosi su una posizione comune. Non a caso il magazine londinese è mezzo tentato di offrire alla battagliera senatrice del Massachusetts il famoso endorsement. Mica saranno le famose convergenze parallele di Aldo Moro? Alla fine molte cose si inventano in Italia.
Di seguito pubblichiamo la traduzione italiana dell’articolo dell’Economist, The alternatives to privatisation and nationalisation, pubblicato sul numero del 12 settembre 2019.
Buona lettura!
La Carta delle foreste
Risuona come vagamente elfico, come qualcosa che sembra uscito dalle pagine di Tolkien. In effetti, la “Charter of the Forest” è uno dei documenti politici fondativi della Gran Bretagna. Risale allo stesso periodo della Magna Carta, nota come la “Great Chart” proprio per distinguerla dal suo omonimo silvano.
Mentre la Magna Carta interessava, li per lì, pochi nobili privilegiati, la Carta delle foreste aveva lo scopo di salvaguardare il tenore di vita dei cittadini comuni. In particolare voleva onorare il loro diritto a procurarsi da vivere dalle generose ricchezze della comune risorsa costituita dalle foreste.
Come istituzione economica, i beni comuni oggi sembrano antiquati come i documenti ceralaccati dell’epoca della Carta. Per molti economisti, la diffusione del diritto di proprietà privata è alla base del mondo moderno. Sta di fatto che l’inefficacia dei beni comuni è stata ampiamente sopravalutata. Oggi questi potrebbero trovare uno spazio importante nelle politiche pubbliche.
La tragedia del bene comune
Un ecologo americano, Garrett Hardin, ha coniato l’espressione “tragedia dei beni comuni” in un saggio (scioccamente eugenetico) pubblicato su “Science” nel 1968. In realtà il problema del free-rider, che affligge da sempre i beni di tutti, è noto agli economisti da oltre un secolo.
Consideriamo un pascolo su cui si possa nutrire il gregge. Ogni utente è spinto a usarlo nel modo più intenso possibile. Dato che è aperto a tutti, la moderazione di un pastore nel lasciarlo brucare dal proprio gregge è un incentivo per un altro a farlo usare più intensivamente dai propri animali. L’erba risparmiata dal gregge del primo pastore sarà l’alimento supplementare del gregge del free-rider. Coloro che si contengono in nome della comune condivisione, alla fine hanno la peggio non solo in termini relativi, ma anche assoluti. Il pascolo comune finirà inevitabilmente in rovina.
Molte altre preziose risorse pubbliche sono, allo stesso modo, soggette alla spoliazione dei free-raider. Le strade diventano congestionate, i corsi d’acqua sovrasfruttati e insozzati e lo spettro elettromagnetico inutilmente sovraffollato. Tutto questo a scapito dell’interesse collettivo.
I due possibili rimedi
In genere ci sono due rimedi. I governi possono regolare per legge l’accesso ai beni comuni, come ad esempio avviene per lo spazio aereo. Oppure, possono cederne il controllo ai privati, istituendo, così, un diritto di proprietà dove prima non esisteva.
Gli economisti tendono a preferire questo secondo rimedio. Sembra il più facile e il più performante. I proprietari privati hanno un incentivo economico oggettivo a utilizzare la risorsa in modo sostenibile, allo scopo di mantenerne il valore più a lungo termine possibile.
La privatizzazione dovrebbe anche favorire gli investimenti e l’innovazione, poiché i profitti che ne deriverebbero arriderebbero al proprietario.
Le recinzioni del XVI-XIX secolo
Molti economisti vedono nella diffusione dei diritti di proprietà un fattore essenziale nel determinare la nascita delle economie moderne. Tra il XVI e il XIX secolo in Inghilterra e nel Galles la terra di proprietà comune fu recintata e affidata a proprietari privati.
Gli storici dell’economia hanno a lungo ritenuto che le recinzioni, sebbene ingiuste e brutali, abbiano stimolato il progresso e creato le condizioni per la successiva industrializzazione.
La coltivazione dei terreni migliorò considerevolmente, e le fabbriche delle città ricevettero dalle campagne la forza lavoro di cui necessitavano. L’aumento della produttività agricola fornì il cibo per nutrire il proletariato urbano.
“La separazione dei contadini dalla terra fu il prezzo che l’Inghilterra pagò per nutrire la sua popolazione in crescita”, scrive Peter Mathias, uno storico dell’economia. E aggiunge: “la rivoluzione industriale parve seppellire per sempre il concetto dei beni comuni”.
Un ripensamento storico
Ma tale ortodossia è stata ampiamente messa in discussione. La privatizzazione delle risorse condivise non porta sempre a un boom della produttività. Ricerche più recenti suggeriscono che le recinzioni potrebbe non essere state quel vantaggio che si pensava essere state per l’agricoltura e l’industria britannica.
Le ricerche di Robert Allen, uno storico dell’economia dell’Università di New York ad Abu Dhabi, hanno mostrato una cosa importante. L’agricoltura delle grandi proprietà capitalistiche, nate dalle recinzioni delle terre comuni, non erano molto più produttive di quanto lo fosse l’agricoltura in regime di commons.
Neppure accadde che i landlord, che avevano acquisito il controllo dei terreni agricoli, incanalassero i loro surplus nell’industria. La maggior parte si dava alla bella vita. Molti erano debitori piuttosto che risparmiatori o investitori.
Guy Standing della School of Oriental and African Studies di Londra nel suo libro The Plunder of the Commons, scrive una cosa molto sensata. I diritti di proprietà possono essere sì un incentivo a utilizzare bene le risorse, ma anche causare lo sperpero dei frutti generati da quelle risorse.
I beni comuni non sono inefficienti
Se la privatizzazione della terra aumentò la produttività meno di quanto ci si potesse aspettare, ciò dipese dal fatto che i beni comuni non erano così tanto più inefficienti della proprietà privata. In effetti, molti beni comuni erano beni curati.
Elinor Ostrom, vincitore del premio Nobel per l’economia, ha studiato il modo in cui i villaggi rurali gestiscono risorse condivise come i sistemi di irrigazione. Il comune svizzero di Törbel, ad esempio, ha condiviso, con successo, le risorse per l’irrigazione per oltre mezzo millennio.
Una focalizzazione esclusiva su pubblico o privato, come modo per controllare l’uso dei beni comuni, trascura un variegato insieme di alternative che si sono sviluppate nel corso della storia. L’era dell’informazione fornisce degli esempi recenti.
Un esempio è Wikipedia, un’enciclopedia libera costruita efficacemente dall’utenza collettiva. Nessun’altra enciclopedia più tenergli testa. Vaste aree del web, che potrebbero funzionare con efficienza come beni comuni, sono state lasciate nelle mani di imprese tecnologiche ricche e relativamente poco responsabili.
Sviluppo del senso civico
Il declino dei beni comuni ha fatto cadere in disuso alcuni importanti principi civici. I cittadini medioevali si aspettavano un beneficio dalla comune proprietà ma aiutavamo anche a gestire la ricchezza sociale condivisa.
In modo analogo, oggi, la prosperità dipende dalla gestione delle risorse pubbliche. Dipende cioè dai comportamenti quotidiani che sostengono lo stato di diritto, dalle conoscenze scientifiche accumulate e dai servizi ambientali incaricati di mantenere l’aria pulita, i corsi d’acqua e così via.
Una certa creatività a livello istituzionale potrebbe consentire di gestire più risorse come beni comuni, riducendo le concentrazioni di ricchezza e potere senza perdita di efficienza economica e operativa.
Un mondo che assegna un ruolo importante ai beni comuni sarebbe un mondo ricco di istituzioni di governo di comunità distribuite e interlacciate tra loro.
Tirare fuori il meglio dalle persone
Sviluppare i beni comuni sarebbe politicamente meno gratificante della privatizzazione. Questa forma consente, infatti, ai governi di scambiare la responsabilità con il denaro. Ma, potenziare i beni comuni potrebbe riparare le pecche del tessuto civile, come le locazioni. Potrebbe anche alleviare il senso frustrazione del cittadino comune nei confronti delle élite che hanno smarrito il contatto con il mondo.
Nella sua conferenza per il Nobel, Ostrom ha affermato che le politiche pubbliche dovrebbero “facilitare lo sviluppo di istituzioni in grado di tirare fuori il meglio dagli esseri umani”. Sembra davvero qualcosa di un grande buon senso.