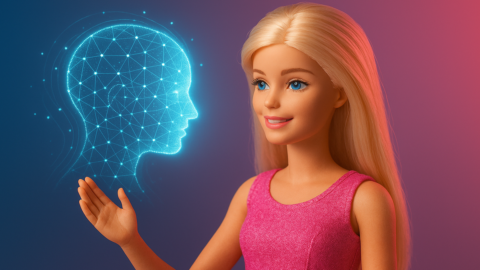The network effect, il carburante delle FANG
Il fenomeno del network effect, o effetto a valanga, governa i rapporti di forza sul web e distribuisce il potere nella nuova economia. L’iniziativa che riesce ad innescarlo, nella propria nicchia o in generale, raggiunge rapidamente e in modo pressoché spontaneo quella massa critica di “clienti” che è uno dei parametri con il quale si misura il valore delle attività online. Grazie al meccanismo a valanga del network effect il valore di un’impresa cresce a dismisura, attraendo così nuove risorse e nuovi clienti per il suo stesso fatto di esistere. Il network effect è veramente uno dei fondamentali delle imprese che operano a qualsiasi livello sulla rete. Il principio del network effect è semplice: il vantaggio e il beneficio che un utente o un consumatore trae da un servizio aumenta con il crescere delle persone che lo utilizzano. Parlando sul “New York Times” del network effect?—?che egli chiama network externality –, a proposito della diffusione planetaria di Windows e di Microsoft negli anni novanta, Paul Krugman scrive:
“Tutti usavano Windows perché tutti usavano Windows. Se avevi un pc Windows e necessitavi di aiuto, potevi chiedere al tuo vicino di tavolo o di pianerottolo e facilmente riuscivi ad ottenere la risposta che cercavi. Il software era creato per funzionare su Windows, le periferiche erano progettate per Windows. Tutte queste network externalaties erano in azione e trasformarono Microsoft in un monopolista”.
Il network effect crea i quasi-monopoli
Venendo a tempi più recenti, nessuno meglio di Amazon ha saputo, grazie a una strategia visionaria, attivare e riprodurre il network effect nell’e-commerce. Similmente hanno fatto Google, Facebook e Netflix nei loro comparti. Una delle conseguenze più immediate dell’effetto a valanga è il frenetico allargamento a nuovi campi di attività, alcuni veramente impensabili, verso i quali l’impresa viene calamitata dallo stesso meccanismo vorace, espansivo, aggressivo e spontaneo del network effect. Le FANG fanno scuola, ma anche la gig economy non scherza. Un esempio recente è proprio quello di Airbnb. Nata come servizio per mettere in relazione chi offre una locazione temporanea e chi la cerca, la start-up di San Francisco non ha impiegato molto ad aggiungere nuovi servizi, inizialmente inimmaginabili. Uno di questi è quello denominato local experiences. Il locatore non solo può affittare il suo locale, ma anche offrirsi, per qualche centinaio di euro in più, come cicerone, guida turistica, chef, chauffeur, giardiniere, insegnante di lingua o skipper. Sono self-driving people della gig economy come li definisce Thomas Friedman. Gli imprenditori del futuro. Lo saranno più o meno tutti.
L’impresa che beneficia del network effect si espande tumultuosamente, diversificandosi rapidamente e ampiamente tanto da trasformarsi in un conglomerato semi monopolista, cioè in qualcosa che sembrava sepolto come un fossile preistorico e che invece è tornato in vita in forme rinnovate. Il prototipo di questo nuovo tipo di conglomerato è Amazon e, come afferma Andrew Ross Sorkin, i nuovi conglomerati assomigliano pazzescamente al colosso di Seattle. Non bastano due mani per contare i settori nei quali opera Amazon. Avremo modo di seguire il ragionamento di Sorkin in un successivo post.
Succede anche che questi nuovi conglomerati sembrano evolversi in dei quasi monopoli che controllano grande parte del business nel quale operano direttamente o con controllate. Questo business va ad impattare come un meteorite i business tradizionali consolidati, quelli che riempiono le caselle del PIL così come è calcolato oggi. Per l’Unione europea queste nuove realtà sono proprio dei monopoli classici o, anche se non lo sono a livello di pura teoria, si comportano come tali e come tali vanno trattati. E allora fioccano le multe e le sanzioni. Negli Stati Uniti, il paese che ha inventato l’antitrust cioè il mezzo legislativo e giuridico per tenere a bada i monopoli, la questione è più dibattuta. E al centro di questo dibattito c’è proprio Amazon che sta mettendo a durissima prova tutto il settore del retail che è uno dei motori della più grande economia del mondo.
I monopoli di Internet sono un male?
Se chiedete a Elizabeth Warren o a Scott Turow, presidente della Gilda degli autori americani, se Amazon sia un monopolio o meno, la risposta istantanea è “Sì, Amazon è un monopolio”. La Gilda ha già inviato un esposto ufficiale al Dipartimento della giustizia chiedendo un’azione antitrust, che però, come vedremo è altamente improbabile. Anche per Krugman Amazon non va bene perché è un monopsomio, cioè qualcosa di speculare al monopolio. Il monopsomio, infatti, designa una particolare forma di mercato caratterizzata dalla presenza di un solo acquirente a fronte di una pluralità di venditori. Nel caso di Amazon questi soggetti economici terzi vendono sulla sua piattaforma di marketplace senza avere serie possibilità di alternative praticabili. Per loro Amazon è un concorrente e un partner, cioè un frenemy (mezzo nemico e mezzo amico). Il corollario di questo bizzarro stato di cose, secondo Krugman, è che Amazon esercita, grazie una mera posizione di potere, “una indebita influenza” (undue influence) sui soggetti economici, e sul loro indotto, che operano sulla sua piattaforma. Un modello elaborato in un recente paper di David Autor (economista del MIT) e di altri mostra come l’affermazione delle imprese superstar del settore tecnologico ha portato a una maggiore concentrazione industriale e a una caduta significativa del lavoro nella ripartizione del valore aggiunto tra i diversi fattori della produzione. Il prototipo di queste imprese sono le piattaforme online che ottengono, rispetto alla loro effettiva attività, una sproporzionata ricompensa che finisce per riallocare il valore tra le varie imprese e tra i fattori della produzione. La conseguenza è che l’economia tende ad essere manipolata e l’innovazione finisce con il favorire l’insorgere del monopolio. Gli studiosi del MIT descrivono così questo cammino verso una forma di monopolio
“Le imprese inizialmente raggiungono una quota di mercato elevata grazie al merito delle loro innovazioni e alla loro superiore efficienza. Una volta, però, che hanno ottenuto una posizione di comando, usano il loro potere di mercato per erigere barriere all’ingresso di concorrenti e per difendere la loro posizione dominante”. A questo punto insorge il monopolio e avvengono i comportamenti monopolistici.
… no, i monopoli di Internet non sono un male
Sulla sponda opposta c’è Peter Thiel, co-fondatore di PayPal e oggi consigliere di Trump per la tecnologia. Secondo il tedesco della Silicon Valley i monopoli di Internet non solo non sono un problema, perché transienti in uno scenario fluido, ma una vera e propria necessità per le imprese che intendono innovare in profondità. Nel suo libro bestseller del 2014, Da zero a uno, sminuisce i vantaggi della concorrenza e celebra il potere dei “monopoli creativi”, che creano valore duraturo e portano nel mondo prodotti e servizi di cui tutti beneficiano.
“La concorrenza significa profitti per nessuno, nessuna significativa differenziazione e lotta per la sopravvivenza – scrive Thiel e aggiunge – I monopoli possono continuare a innovare perché i profitti gli permettono di fare programmi a lungo termine e finanziare ambiziosi progetti di ricerca che le imprese che operano in una situazione di concorrenza possono solo sognare. Il monopolio è la condizione di ogni business di successo”.
Come dicevamo Thiel occupa una posizione importante nell’amministrazione Trump che, sostanzialmente, converge sulle sue posizioni fino a quando le azioni dei cosiddetti monopoli creativi, ubicati nella Silicon Valley, non collidono con gli interessi e la politica dell’amministrazione. Allora la musica cambia come è accaduto ad Amazon quando Trump, a causa delle inchieste del Washington Post, ha accusato Jeff Bezos di brigare per evitare che la politica guardi “nel monopolio esentasse di Amazon”. Ma Amazon è davvero un monopolio?
Secondo Herbert Hovenkamp, professore di legge alla Università della Pennsylvania ed esperto in legislazione antitrust, Amazon non è un monopolio se consideriamo i parametri classici che la legislazione USA individua come peculiari di un monopolio. Un monopolio si ha quando una società domina a tal punto il mercato di riferimento da poter ridurre il suo approvvigionamento e causare un aumento dei prezzi in un periodo di tempo medio-lungo con danno per i consumatori. Si dà l’esistenza di un monopolio quando ad essere danneggiati sono i consumatori, non quando lo sono i concorrenti dell’impresa presunta monopolista. La maggior parte delle rimostranze contro Amazon viene dai concorrenti, non dai consumatori che invece collocano Amazon in cima alla lista dei loro servizi preferiti. La legge, inoltre, definisce un monopolio quando si stima che l’impresa controlli il 70% di un mercato. E Amazon è ben al di sotto di questo tetto in quasi tutti i settori in cui opera. Nel 2000 Microsoft fu colpita dalla normativa antitrust perché si valutava che il suo prodotto più importante, Windows, avesse una quota di mercato del 90%. Nessun tribunale, corte federale o Federal Trade Commission, conclude Hoverkamp, hai mai intrapreso una azione antitrust contro Amazon. E lo ha fatto a ragion veduta. La posizione di Google e di Facebook è più compromessa visto che controllano rispettivamente il 90% e l’89% dei loro mercati. Infatti Google è stata colpita in Europa e Facebook rischia qualcosa di analogo.
Amazon ha però dei tratti che mal si riconducono allo stereotipo del titano di Internet. Occupa un sacco di gente, come si può vedere dal grafico sopra. Un aspetto che non è sfuggito a Mark Vandevelde, il global retail correspondent del “Financial Times”. Vandevelde ritiene, contraddicendo le conclusioni del gruppo di economisti del MIT, che la fortuna di Amazon non è avvenuta distruggendo posti di lavoro o sostituendoli con le macchine, ma accrescendo il contributo del lavoro all’economia. Ha infatti creato più posti di lavoro di quanto ne abbia distrutti. Leggendo uno studio condotto da Michael Mandel, un economista del Progressive Policy Institute di Washington, si nota questo fenomeno. Se includiamo nel commercio al dettaglio anche i lavoratori dei centri di immagazzinamento e smistamento e della logistica, la forza lavoro occupata nell’e-commece ha superato, nel 2016, di 54.000 unità quella perduta nel commercio al dettaglio tradizionale. Inoltre Mandel stima che i lavoratori dell’e-commerce siano più produttivi e meglio pagati dei loro colleghi nel commercio tradizionale. È vero che Amazon sta ricercando e sperimentando nuove tecnologie nella gestione del magazzino e delle consegne così da ridurre il personale e i tempi di esecuzione e di conseguenza i costi, ma i progressi in questo campo, osserva Vandevelde sono molto lenti.
La proposta di Zingales e Rolnick
Su un punto però, almeno negli Stati Uniti, c’è una certa convergenza. L’attuale regolamentazione antimonopolistica è obsoleta. Ci sono ancora dei buoni principi, ma il quadro generale di riferimento è del tutto cambiato. Neppure una rinnovata regolamentazione appare la soluzione più idonea. Il concetto stesso di regolamentazione è messo in discussione Come si fa a spezzare o distruggere qualcosa che i consumatori pongono all’apice della loro soddisfazione, come succede con Google, Facebook o Amazon? L’antitrust è nato per tutelare i consumatori, non per dargli dei pugni in faccia.
L’unica via possibile appare quella di ricercare dei meccanismi di bilanciamento del network effect in modo che possa risultare più distribuito tra tutti gli operatori del settore. L’idea di Luigi Zingales e Guy Rolnick, della Università di Chicago, è quella di portare all’interno delle piattaforme proprietarie e chiuse alcuni servizi di scambio e di portabilità delle attività del cliente volti a tenere in vita e stimolare la concorrenza. Per esempio un utilizzatore di una corsa di Uber potrebbe pagarla con il proprio account Lyft o viceversa. Quando si cerca un mezzo dall’applicazione di Uber o di Lyft succede che sono offerte anche le soluzioni disponibili della concorrenza.
Parlando dei social network ecco che cosa scrivono i due economisti di Chicago:
“Per un problema del 21° secolo, suggeriamo una soluzione del 21° secolo: riallocare per via legislativa i diritti di proprietà così da stimolare la concorrenza… È sufficiente assegnare a ciascun consumatore la proprietà di tutte le connessioni digitali che crea, cioè quello che è noto come il social graph. Se una persona possiede il suo social graph può accedere a un competitor di Facebook?—?chiamiamolo MyBook?—?e immediatamente portare su questo network tutti gli amici e i messaggi di Facebook, così come avviene con la portabilità del numero sul mobile”.
Occorre dunque una sorta di Social Graph Portability Act, cioè una sorta di portabilità inter-piattaforma di tutte le attività online di una persona. Questa azione ridurrebbe le dimensioni il network effect e ne distribuirebbe l’efficacia e i benefici, così da evitare la monopolizzazione della tecnologia. Si tratta di una proposta molto interessante e anche visionaria perché va a modificare in profondità l’assetto attuale dei social media e delle attività su Internet in una direzione che non piace affatto ai monopoli creativi. Sarebbe una battaglia delle Termopili, ma forse vale la pena di essere combattuta, anche se sarà una battaglia perduta che lascerà un traccia.