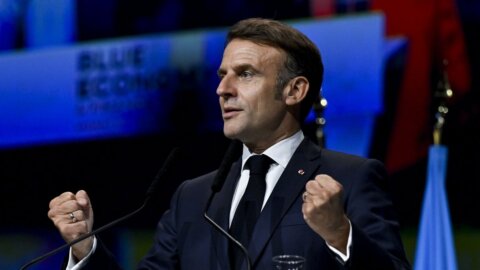I numeri dicono che Joe Biden potrebbe ancora farcela per il rotto della cuffia, a mezzogiorno del 4 novembre ora continentale europea. Ma gli stessi numeri dicono che Donald Trump potrebbe sì perdere, ma di strettissima misura e quindi potendo sempre dire che mezza America è stata con lui sino alla fine. Ed essendo Trump dirà, lo ha già detto, che il voto è stato, sarebbe stato, rubato, mentendo spudoratamente. Il voto postale è controllato, affidabile e i tentativi di frode sono sempre stati dello 0,00007 per cento circa. Comunque Trump spaccherà ancora di più il Paese in due, se vince perché ha vinto e se perde perché ha perso.
Con gli Stati già attribuiti, informalmente ma con piena credibilità, a un vincitore, Biden ha a mezzogiorno del 4 novembre 225 voti nel collegio elettorale (quello che fa il Presidente) e Trump 213, e ne servono 270 per vincere. Gli Stati in bilico sono sette, Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada e Arizona; in due, Pennsylvania e North Carolina, le regole impongono di aspettare fino al 6 e al 12 Novembre per scrutinare schede postali che arrivassero tardi ma spedite comunque entro il 3 novembre. A questo punto si possono intravedere diversi scenari e fare vari calcoli delle probabilità, e queste pencolano forse più a favore di Trump che di Biden, ma la cosa più seria è aspettare. Pennsylvania e North Carolina saranno comunque attribuibili prima delle scadenze legali, che vanno attese per le proclamazioni ufficiali.
A caldo, la prima conclusione politica da trarre è che anche se esce dalla Casa Bianca Trump non è stato davvero sconfitto. Questo voto conferma che, nonostante quattro anni vissuti da mezza America tra la preoccupazione e l’orrore, nonostante il semi negazionismo sanitario sul Covid, nonostante l’evidente strategia di dividere il Paese e non di unirlo sui temi razziali e della grande cultura civica, e nonostante molto altro tra cui il crollo dello standing e della leadership morale americana nel mondo, Donald Trump è ancora in vetta alla politica americana e può legittimamente sostenere di esserne, a cavallo tra seconda e terza decade del secolo, la figura più rappresentativa. All’elettorato di Trump non importa molto dello standing, anzi come il loro idolo dicono che averne meno è un bene perché restituisce mano libera al loro Paese che quindi fa più paura e alla fine avrà più…standing.
Dal nostro punto di vista di europei, attenti più che alla politica interna americana alle conseguenze di questa sulla sua politica estera, si tratta di una sciagura e per un motivo molto semplice. A un secolo dai primi decisi passi americani verso la leadership mondiale, passi compiuti durante e dopo la Prima guerra mondiale e conclusi dopo la Seconda, gli elettori americani hanno premiato, e questo dato resta anche se Trump dovesse vedersi rifiutare un secondo mandato, l’uomo che sconfessa a colpi di twitter e di iniziative presidenziali la politica di una dozzina di predecessori, e senza definirne una nuova, se non lo sconquasso da “guerra di corsa”. Non tutto ciò che Trump ha fatto è sbagliato, ma certamente non ha saputo né voluto definire logiche e procedure nuove.
L’America si lanciò nel ruolo leader, scalzando prima solo finanziariamente e poi anche politicamente la Gran Bretagna, per meglio servire i propri interessi e facendo di New York la capitale finanziaria del mondo, già un secolo fa. Trump butta tutto a mare, pratica una “guerra di corsa” che non riconosce alleati o li sceglie a geometria molto variabile e sostiene che questo servirà meglio gli interessi americani; non saprebbe dire una parola su come e con quali uomini la finanza americana creava già ai tempi dei bisnonni il proprio potere, ma pontifica alla grande. E, questo è il punto, non meno di 100-120 milioni di americani gli credono.
Da noi c’è chi si affida, per leggere l’America di oggi, a schemi marxisti di lotta di classe per i quali Trump rappresenterebbe non i poveri ma gli impoveriti e gli altri sarebbero l’élite pseudo intellettuale che disprezza gli impoveriti. Ma non è il caso di disturbare Marx. Gli Stati Uniti hanno seguito nei rapporti ricchi/poveri, centro/periferie, centralismo amministrativo contro autonomie locali, logiche e schemi tutti americani basati sul rapporto difficile, sempre difficile salvo poche stagioni, tra common man ed élites, in nome di un robusto populismo, meno improvvisato di quello europeo, ma ugualmente radicale. La stagione trumpiana è l’ultima incarnazione di questo schema populista. “Vi hanno rovinato, vi disprezzano e io vi salverò e vi difenderò”. Questo il messaggio e questo, la lunga tornata del 3 Novembre lo conferma, è passato.
Il messaggio di Biden è stato “Possiamo fare molto meglio di ciò che abbiamo sotto gli occhi, noi non siamo così”, ed è passato solo a metà. L’America di oggi, il 2016 non è stato un incidente, è quella che Trump si è trovato già confezionata. Lui non ha creato, ha solo sfruttato una lenta erosione del ruolo del Congresso, dove non ci sono più personalità forti e buoni conoscitori della politica estera; ha sfruttato l’emarginazione dell’alta burocrazia soprattutto del Dipartimento di Stato a tutto vantaggio della Casa Bianca, con il National Security Council passato dalle 50 persone di Bush padre alle 400 di Obama, a tutto svantaggio dei diplomatici; ha sfruttato la polarizzazione politica che tappa la bocca a tutti i critici interni allo schieramento. Ma tutto questo c’era già prima di Trump. Trump è il prodotto di quell’America dove un gruppo di giovani deputati repubblicani neoeletti nel 1994, la stagione del pirotecnico Newton Gingrich oggi grande sostenitore di Donald, diceva di non possedere un passaporto e se ne vantava come bandiera del vero americanismo. E noi del mondo ce ne freghiamo, come si diceva una volta in Italia. Questo è il trumpismo. Più ancora che degli auguri di vittoria, Joe Biden avrebbe bisogno di auguri di riuscire a fare qualcosa di buono nel caso la vittoria dovesse, in extremis, essere sua.