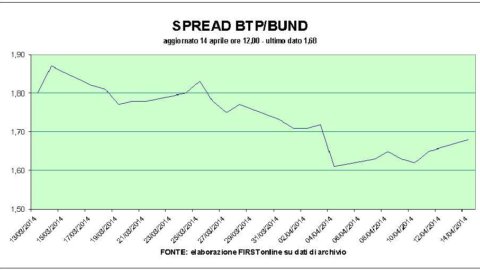Il farmacista di Alanno avrebbe voluto essere un contadino, di quelli che quando vanno a messa col vestito buono della domenica, portano foglioline di basilico nell’incavo tra l’orecchio e la tempia, come fanno i falegnami con la matita. Avrebbe voluto avere mani tozze, secche, screpolate per i lavori di campagna; tornare a casa e, dopo aver mangiato sagne e ceci al sugo di pomodoro, sgroppare la moglie sul tavolo da cucina, senza cerimonie, sbrigativo e con gusto, come quando si sorseggia un buon caffè ma si ha fretta di andare. Poi, dopo aver cacciato un sonoro rutto acido, aromatizzato ai peperoni mangiati la sera prima, avvicinarsi lentamente alla finestra e, con lo stuzzicadenti in bocca e le mani in tasca, guardare fuori il grano che cresce.
Invece non aveva niente del contadino se non l’andatura pigra e appena dinoccolata. Non era alto, né magro. Portava gli occhiali. Aveva pochi capelli e un po’ di pappagorgia. Dava più l’impressione di un impiegato dell’ufficio anagrafe. Non quelli che stanno allo sportello, quelli che non si vedono mai perché lavorano nelle stanze interne, presso gli archivi. Quelli con la pelle bianca e gelatinosa per mancanza di sole, e le occhiaie livide e umide per mancanza di donne.
Secondo il farmacista i contadini erano una razza pura, selezionata da millenni di contatto con la Natura. Da questa avevano preso la saggezza, i gesti, il linguaggio. Avrebbe voluto essere uno di loro, e percepiva questa occasione mancata come una continua inconsolabile nostalgia.
In farmacia, quando entrava un contadino e si spandeva il suo buon odore di stalla, inspirava aria per ossigenare i polmoni, come fosse in alta montagna. E si animava. Il sangue tornava a scorrergli nelle vene. Subito cominciava a lamentarsi per la pioggia che impediva la semina; malediceva la grandine come se ne avesse avuto un danno; quando era tempo di vendemmia dava consigli sulle dosi di bisolfito da aggiungere al mosto, e raccomandava di rispettare le lune per il travaso. I contadini ormai non lo ascoltavano più, ma lo ringraziavano. Ringraziamenti volti non a quegli inutili suggerimenti, ma alla candida e infantile amicizia che quel fanciullone di 60 anni, fragile, sprovveduto e stravagante, offriva loro con una premura eccessiva, ma sempre rispettosa, ingenua, sincera.
La giovane fornaia fu la prima cliente di quel pomeriggio. Era piccola e rotonda. Portava sempre con sé l’odore caldo delle pagnotte appena sfornate. Parlava in fretta ed emetteva risolini musicali che le avevano procurato il soprannome di Cinciallegra. Nel paese tutti ne avevano uno.
Per sopportare il caldo del forno, anche d’inverno vestiva come fosse piena estate. Quando in farmacia si chinava in avanti poggiando i gomiti sul bancone, la camicetta mostrava tutto il suo contenuto. In altri tempi quella visione avrebbe reso felice la giornata del farmacista, e fornito lo spunto per lunghe, estenuanti meditazioni. Adesso l’interesse, sebbene ancora un po’ desto, si perdeva nei mille rivoli della memoria e, chissà perché, gli venivano in mente le bombe alla crema: non quelle fritte, quelle cotte al forno. Da liceale ne andava pazzo. E così, proprio mentre rifletteva sul mestiere del pasticciere, che immaginava con le mani sull’impasto, la fornaia gli disse che Zio Glauco, dal balcone, oltre a ordinare il pane, lo informava di aver terminato la scorta di aspirine. Si deve chiarire che Glauco, il tabaccaio, per tutti era diventato presto Zio Glauco: il suo soprannome, venuto fuori perché lo chiamavano così i bambini del Borgo che giocavano con i suoi due veri nipoti. Era a letto con la febbre. Giovanni, il farmacista, suo nipote naturale, sapeva che lo aveva chiamato anche per chiacchierare, raccontare, inventare storie, come faceva cinquant’anni prima, quando tornava da Roma il sabato sera.
Chiusa la farmacia, con le mani in tasca per il freddo, il nostro eroe s’incamminò per andare da suo zio. Bastava scendere per poco più di cento metri e si arrivava al Borgo: una piazzetta chiusa a cerchio da robuste case in stile patriarcale, abitate soprattutto da contadini che avevano i terreni poco distanti. Il farmacista era nato in una di quelle case. Si era trasferito nella zona superiore del paese con la madre e Umberto, suo fratello minore, quando aveva nove anni: l’anno in cui era morto suo padre. E in quella casa così grande era rimasto solo suo zio: lo Zio Glauco.
In quel periodo attraversava spesso la piazzetta del Borgo, perché, oltre che allo zio, faceva visita ad Antonio, uno dei suoi più cari amici d’infanzia chiuso in casa da più di un anno perché malato.
Il Natale era prossimo. Le luminarie ardevano già da un paio d’ore. Avrebbero dovuto indicare un’allegria che lui non avvertiva. Una volta quelle luci gli davano gioia e malinconia, adesso le sentiva ostili, come se avessero fastidio ad ardere anche per lui, e sotto quelle lampadine in festa si sentiva un intruso.
La sua filosofia sugli esseri umani era semplice: alle persone belle il mondo sorride, e fa i versacci a quelle brutte che, per non soccombere, sviluppano il talento della simpatia. Quando sei con loro ti viene il buonumore; sono sempre allegri e pronti al riso. I brutti sanno raccontare le barzellette; i belli no, perché non hanno mai avuto bisogno di farlo.
Lui non apparteneva né ai belli né ai brutti, perché era insignificante. Per sopravvivere, nella sua mente aveva costruito un mondo parallelo. In questa diversa dimensione s’innamorava spesso delle sue clienti. Le preferiva sposate, malinconiche e sofferenti, perché gli piaceva credere che i mariti le trascurassero, addirittura le picchiassero, ma soprattutto che non riuscissero a valutare la morbidezza della loro pelle, il suono della loro voce, e il collo. Sì il collo, per il farmacista luogo di perdizione, dove si concentrava tutta la femminilità di una donna. A sera, prima di addormentarsi, passava in rassegna le più belle del paese, e le immaginava a rassettare, pulire, stirare, rammendare e, dopo cena, con l’espressione del condannato che si avvia al patibolo, andare a letto col marito. Così trascorreva i suoi giorni. Così era trascorsa la sua vita.
Passò per la discesa di Tarcisio e poi girò all’angolo, dopo aver salutato la moglie di Tullio che innaffiava i gerani sul balcone.
***
Arrivò alla casa di Zio Glauco, dove era nato, dove era custodita la sua vita da fanciullo: quella trascorsa nel Borgo, quando era ancora vivo suo padre; quando la timidezza non lo aveva ancora ghermito, quando era ancora capace di correre per liberare la sua gioia di vivere.
In quella casa nessuno entrava per il portone. C’era un cancelletto laterale sempre aperto, da cui, per un vialetto di pochi metri, si accedeva al cortile posteriore, e da qui si entrava in casa dalla porta della cucina, mai chiusa a chiave. Il cortile era delimitato tutto attorno da un muretto basso che, con la parete della casa, formava un rettangolo. Oltre il muretto, verdi abeti racchiudevano quello spazio e lo isolavano dal mondo. Era lì che una volta si svolgeva la vita estiva della sua famiglia.
Ora vi abitava solo Zio Glauco, fedele guardiano della casa e dei suoi ricordi. Dalla parte opposta allo sbocco del vialetto nel cortile, invisibile alla piazzetta del Borgo perché nascosta dalla casa, il muretto s’interrompeva per dare accesso a una piccola radura racchiusa da un gruppo di alberi a cerchio. Erano acacie. Tra queste alcuni ciliegi. Faceva pensare a una bomboniera. Zio Glauco lo aveva chiamato Il giardino dei ciliegi in onore di Cechov. Quando ne parlava lo indicava come il poeta e mai come lo scrittore. Lì si organizzavano picnic, lì da piccolo, Giovanni, suo fratello e lo sciame dei loro amici del Borgo avevano fissato la sede principale per giocare a nascondino e prendere le decisioni più importanti per le loro monellerie. Lì festeggiavano compleanni, onomastici e tutti i santi che nel calendario capitavano di domenica e nei giorni di sole.
A volte di sera, all’uscita, dopo la visita allo zio, al buio, Giovanni entrava nel giardino dei ciliegi. Vi rimaneva immobile, in silenzio. Le piante in fiore profumavano intensamente, come molti anni prima, tanto che gli sembrava di udire le grida degli amici che giocavano con lui da piccolo. Ne rincorreva le voci. Tra queste riconosceva anche la sua, che gli procurava una profondissima pena, come per un caro amico scomparso.
Giovanni salì in camera dello zio senza bussare e senza accendere la luce. Avrebbe potuto camminare anche ad occhi chiusi. E a occhi chiusi sarebbe stato in grado di riconoscere l’odore di quella casa. Era convinto che la combinazione dei vari odori delle spezie usate per cucinare, mescolati all’odore di chi vi abita costituisse una sorta di carta di identità: l’alito, il dopobarba, il dentifricio, la cromatina usata per lucidare le scarpe e la marca di sigarette fumate. Era certo che in quell’odore unico, identificatore, fosse nascosto il patrimonio genetico di tutta la famiglia che vi abitava, e non solo: anche la sua storia, i momenti terribili e quelli rari di felicità che pure attraversano la vita di ognuno.
Entrando nella sua vecchia casa gli piaceva ritrovare lo stesso odore.
Zio Glauco stava leggendo un libro di poesie. Appena si accorse della visita, lo chiuse e, come se continuasse un dialogo iniziato da ore:
«Ogni poesia ha il suo baricentro. “Fanciullo” è il baricentro del Sabato del villaggio. “Godi, fanciullo mio, stato soave …” La poesia è appesa a questa parola, come un vestito appeso ad un chiodo. Se togli il chiodo crolla tutto.» Poi, indicando con gli occhi la sedia: «Hai fretta? Vai da Antonio?».
«Sì» rispose il nipote sedendo sul letto e stringendo con la mano il collo di un piede dello zio attraverso le coperte.
«Il medico mi ha detto che non vedrà l’anno nuovo.»
«Lo ha detto anche a me», e dopo un po’: « Tu, come stai?». Solo con suo zio e i suoi amici del cuore, Antonio e Pasqualino, riusciva a togliersi di dosso la timidezza e quell’aria impacciata che lo rendevano diverso dagli altri. Una diversità da cui non riusciva a sottrarsi. Come una balbuzie che insorgeva non voluta, inesorabile.
«Solo un po’ di febbre.»
«Domani starai in piedi.» Giovanni cominciò ad alzarsi lentamente, come un vecchio pieno di reumatismi. Posò la scatola di aspirine sul comodino. Poi, quando arrivò alla porta, aggiunse: «Ci vediamo».
Lo Zio Glauco tirò le coperte sino al mento: «Sai, morire per una febbre o per un foruncolo infettato è avvilente».
Giovanni rimase in piedi appoggiato con una mano ad un’anta della porta aperta, senza parlare. Gli sembrava uno di quei momenti in cui Zio Glauco cominciava a creare favole, storie, sogni. Ma quella volta si limitò solo ad aggiungere:
«Questa febbre non fa per me.»
«No?»
«No. A me piacerebbe morire… nel mezzo di una sparatoria.» E scoppiò a ridere.
«O come Leslie Howard nella Foresta pietrificata?!»
«Sì, bravo.»
«Ti saluto» aggiunse Giovanni dopo un po’.
«Una cosa non riesco ad accettare della morte. Ne parlavo con Antonio.»
«Cosa?»
«Che non posso raccontarla. Un accidente così importante, e non puoi raccontarlo! Rimasero un po’ in silenzio.»
«Domani passo.»
«Salutami il Pittore.»
***
Il Pittore era il soprannome di Antonio. Abitava con sua moglie nella casa a fianco di quella di Zio Glauco. Era coetaneo e, insieme a Pasqualino, detto il filosofo, amico fraterno del farmacista. Quando erano ragazzi si divertivano a fare pipì sul bianco muro di cinta della casa di Zio Glauco. Antonio era il più bravo. Era capace di disegnare un cerchio perfetto. Da qui il soprannome. Andavano alla fontana a bere per riempirsi di acqua. Dopo mezz’ora erano di nuovo pronti a dipingere.
Poi si erano fatti grandi. Quando per la piazza del Borgo passava una ragazza, i giovanotti si sentivano autorizzati ad un commento. E venivano fuori frasi in codice come “canne al vento” per bocciare una ragazza troppo magra, oppure “culo ballerino”, “latte per tutti” e così via. Antonio invece, che già lavorava nella macelleria del padre, usava termini che appartenevano ad una diversa categoria semantica. Intanto di una ragazza sapeva indicare il peso e il numero di bistecche che avrebbe potuto ricavare dal costato. E dopo aver valutato la consistenza dei lombi, quando c’era necessità della lode, il commento era: “Cammina come una pecora prima della tosatura”.
Fu Dora, la moglie di Antonio, ad aprire la porta. C’era col farmacista quella tacita intesa che nasce dall’essere stati da piccoli compagni di giochi. L’accompagnò in camera da letto senza dire una parola. Antonio era in piedi, alla finestra. Guardava la piazza tenendo la fronte appoggiata al vetro. Giovanni si avvicinò e si fermò a guardare anche lui la piazza del Borgo. Antonio, senza voltarsi: «Vedi quelle donne? Anche dopo la mia morte continueranno ad andare alla fontana per riempire la conca. Poi la metteranno in equilibrio sulla testa, e dritte, come regine vatusse, torneranno nel tepore della loro casa. La vita sarà la stessa, sempre. Questo è quello che conta». In quel momento passò Alberto. Aveva lavorato la terra tutta la vita, un vero contadino, e adesso, in vecchiaia, racimolava qualcosa come calzolaio. Antonio aggiunse con un tono di meraviglia: «E poi sento una specie di affetto appassionato, una pietà per tutti. Persino per quello stronzo di Alberto. Non ci parliamo da quando mi voleva vendere quella capra azzoppata. Ricordi? Ma chissà che la fregatura gliela stessi dando io che la volevo per niente. Insomma adesso me lo abbraccerei, quello stronzo. Sempre con la faccia da martire. Eppure gli voglio bene. Sento una pena per la sua vecchiaia, per l’amore silenzioso, riservato, con cui assiste la moglie. La tiene come una regina, quella mezza strega. Ma abbraccerei anche lei. Quella befana con i baffi!». Poi, lentamente, se ne tornò sulla poltrona vicino al letto aggiungendo con un sospiro: «Per far girare il mondo nel verso giusto dovremmo essere tutti prossimi a morire». Prese il giornalino delle parole crociate e, come se leggesse: «Zio Glauco?».
«Sta bene», rispose Giovanni sedendo di fronte a lui sulla ben nota poltrona spelacchiata, con le molle rotte ma comodissima. Accavallò le gambe e incrociò le dita delle mani dietro la nuca. Poi aggiunse: «Come ti senti oggi?».
«Benino. Un po’ meglio.» Poi, dopo un sospiro, puntando i gomiti sui braccioli per tirarsi su e in avanti, a bassa voce: «Devo parlarti di una cosa che ti sembrerà strana, forse pazzesca, ma è importantissima per me… che sto morendo. Scusami se ti parlo in modo crudo, ma non posso essere approssimativo, tutto deve essere chiaro».
Anche Giovanni si sporse in avanti. Antonio, a voce bassa, per impedire che Dora sentisse, continuò tra mille pause di imbarazzo: «L’idea di morire è diventata un’ossessione. Non vedo l’ora di liberarmene. Sì, ho paura, ma io dico… ci sono migliaia di persone che muoiono ogni giorno. Se ci riescono gli altri ci riuscirò anche io… Ma non è di questo che ti voglio parlare… Non so come cominciare… Si tratta di Dora… Sai come succede, dopo un po’ che sei sposato diventa tutto un’abitudine. E tua moglie non la tratti più come una regina… ma come una serva. Insomma sono pieno di rimorsi. Hai fatto bene tu a non sposarti…»
«Io non mi sono sposato perché non ne sono stato capace.»
«Sta zitto, di’ piuttosto che non hai mai voluto ascoltarmi. Ma adesso lasciami dire, prima che entri Dora… L’altra notte ho avuto dolori insopportabili. Non mi ha lasciato solo un momento. È così cara, affettuosa. Ma questo lo sai… Insomma, a maggio scorso, io già stavo male, le feci portare un mazzo di fiori: era il suo compleanno. Sul biglietto scrissi una frase d’amore… senza firmare… Pensavo sarebbe stato più divertente far crescere la curiosità, e poi dirle la verità… In cucina, quando lo ricevette, c’era Anna, la moglie del maresciallo. Si confida solo con lei. Insomma per l’innamorato misterioso, a tutti hanno pensato tranne che a me. Io sentivo tutto. Anna fantasticava e nell’elenco dei possibili corteggiatori mise il sindaco, la guardia comunale e poi risero tanto quando alla lista aggiunsero il parroco. A quelle risa mi sono sentito così estraneo. E ho subito capito che se Dora avesse saputo che ero stato io a inviarle i fiori, sarebbe stato come averle regalato crisantemi. Da anni non la sentivo così divertita. Io non faccio più parte di questo mondo. Ed è normale. Normalissimo… Non abbiamo avuto figli. L’unica cosa che mi consola è che almeno ha quest’amica. Anche tu, dopo, cerca di frequentarla, non lasciatela sola come un cane.»
«E allora? Sei geloso?»
«No, no, non capisci niente, per la miseria! Non sono geloso. Sto morendo, per me non esistono più queste scemenze.» Stremato, si afflosciò sullo schienale della poltrona.
«Non ce la faccio neanche a parlare.»
«Non ho capito cosa mi vuoi dire.»
«Ti voglio dire che nelle risposte di mia moglie si sentiva quel sottile, timido piacere della lusinga.»
«Allora sei geloso!»
«No, amico mio. Sii serio. Non ho altri a cui chiedere questo favore. Sii serio!»
«Un favore?!»
«Sì, un favore», e si sporse di nuovo avanti reggendosi sui gomiti. «Voglio lasciarle questa lusinga. Voglio che almeno questo abbia da me. Non ho altro da darle.» E si accasciò di nuovo sulla poltrona. Dopo un po’ di silenzio, come per dare il tempo all’amico di riflettere e capire: «Tu devi mandarle un mazzo di fiori ogni suo compleanno. Il prossimo lo compirà il 28 maggio. Io sicuramente non ci sarò. Devi fare solo questo. E adesso scusami, non ho più la forza di parlare».
Stettero in silenzio. Dopo un po’ Giovanni si alzò e, con la naturalezza di chi si muove in casa propria, lentamente, andò alla finestra. Non quella che guardava la piazza con la fontana, ma quella da cui si vedeva la casa di Zio Glauco, vicinissima. Antonio disse: «Stai pensando a quante volte abbiamo pitturato quel muro?». Era vero, e Giovanni assentì con un sorriso. Poi gli andò vicino. Antonio, con gli occhi chiusi, ansimava, come se avesse appena terminato una lunga corsa. Era accasciato sullo schienale; la testa leggermente piegata da un lato. Giovanni gli sfiorò la guancia col dorso della mano, e disse: «Oggi non ti sei rasato», e poi: «Ci vediamo domani». Antonio, sempre ad occhi chiusi, immobile: «Lo dimentichi?».Giovanni rispose con un semplice no, e uscì dalla camera.
Dora, seduta al tavolino della cucina, pelava le patate. Era ancora bella. Non molto diversa da quando, alle superiori, vinceva le gare del salto in lungo. Non era alta ma, così snella, lo sembrava. Il viso ovale manteneva ancora la sua grazia, forse per il nasino piccolo sul quel volto bianco, luminoso come il verde dei suoi occhi. Annodato dietro la nuca, un fazzoletto celestino chiaro teneva raccolti i capelli grigi. Indossava sempre una tuta da lavoro con bretelle. Da lontano sembrava un operaio. Un metalmeccanico. Ma da vicino era un piacere constatare quanto quella divisa mascolina contrastasse con la femminilità del suo collo lungo, elegante e il suo sorriso parsimonioso, ma sempre franco e ospitale. I suoi modi delicati, signorili e composti avevano qualcosa di pudico che traspariva anche dalla voce. Quella schiena sempre dritta, da atleta, le conferiva una presenza seriosa, quasi austera, anche in momenti come quello: seduta a pelare le patate.
Si alzò subito, come fosse stata colta a fare qualcosa di proibito. Si pulì le mani allo strofinaccio da cucina che era sul tavolo e, senza parlare, andò alla porta. Giovanni uscì ricambiando il sorriso che Dora aveva appena abbozzato mantenendo l’anta della porta aperta e guardando per terra. Era di pochissime parole. Chiunque, non conoscendola, l’avrebbe presa per sordomuta.
Fuori era umido e freddo. Giovanni si volse a guardare la facciata della casa di Antonio. Pensò che presto vi avrebbero incollato il manifesto della sua morte. Immaginò quando avrebbero messo il proprio. Al funerale sarebbero andate non più di cinque o sei persone. Tutto quel soffrire e amare, tutti i ricordi, sarebbero andati persi. In paese era l’unico a non avere un soprannome perché era un uomo opaco, dai contorni imprecisi, era invisibile, inesistente. A volte pensava di esserlo già, morto. Mentre saliva per la strada di Tullio rifletteva su tutto questo e gli sembrava che la vita lo avesse dimenticato.
Zio Glauco almeno una volta al giorno andava da Antonio, che solo con lui parlava apertamente della sua prossima morte come si trattasse della trama di un film. Tra l’altro si misero d’accordo che, dopo il funerale, la sera stessa, Zio Glauco avrebbe dovuto tenere accesa una candela vicino alla finestra. Antonio l’avrebbe spenta tre volte di seguito. Un saluto, un segnale che di là la vita continua.
Si videro altre sere. In una delle ultime Giovanni andò con Zio Glauco e Pasqualino, il filosofo. Quella volta non ci furono silenzi imbarazzanti. Antonio era eccitato. Parlava sempre lui. Ricordava a uno a uno i racconti romani di Zio Glauco. Li riceveva di seconda mano da Umberto, il fratello minore di Giovanni. Ricordò i primi amori nati attorno alla fontana della piazzetta del Borgo. Attorno a essa era cominciata la storia con sua moglie.
Mentre uscivano, prese il braccio di Zio Glauco e gli disse: «Mi raccomando la candela!». E scoppiò in una risata di gusto. Appena fuori Pasqualino commentò: «Sarà poi un bene che esista un aldilà?».
«C’è chi cammina per strada ma è già morto» rispose Giovanni.
Si salutarono, e ognuno prese per una diversa direzione. Il farmacista sapeva che una volta tornato nella propria casa, aperto il portone, avrebbe sentito quell’odore di sartoria, di vecchio, per i vestiti riposti ad ammuffire negli armadi.
***
Arrivò la primavera. Antonio era stato sepolto nella cappella di famiglia alla fine di gennaio.
Dora prima di andare a dormire guardava la candela accesa in casa di Zio Glauco. Dietro la finestra le sembrava che si agitasse in una sorta di saluto. Ma il tempo passava, e la voglia di staccarsi dai ricordi della malattia del marito cominciava a farsi breccia nel suo cuore, prima ancora che nella mente.
Giovanni mantenne la promessa: inviò fiori a Dora il giorno del suo compleanno. E questo, complice anche il vento di primavera, riattivò l’arrugginita fantasia di Dora, ma soprattutto infiammò quella di Anna, che cominciò a fermentare e a estrarre, come da un cappello di un mago, le ipotesi più assurde.
Una sera, dopo essere stato da Zio Glauco, Giovanni passò da Dora per consegnarle delle medicine. Era rossa in viso per la febbre. Prima di uscire, rimanendo fermo sulla porta, mentre le dava qualche ultimo consiglio, rifletteva che Dora non aveva pronunciato una sola parola da quando era entrato. Le raccomandò di coprirsi meglio perché si era abbassata la temperatura. Allora accadde che lei, sempre senza parlare, prese un maglione poggiato su una sedia lì vicino, e lo indossò davanti a lui. Era di lana, avana chiaro, e forse per i continui lavaggi si era rimpicciolito. Così Dora, accompagnando i movimenti a buffe smorfie per gli sforzi, prima infilò la testa, poi le braccia allungandole in alto. Per alcuni secondi il maglione rimase stretto e arrotolato come una ciambella, sotto le ascelle e sopra il seno che, in quel modo, strozzato, evidenziò tutta la sua solida e abbondante consistenza. Poi finalmente tirò giù l’orlo del maglione che la coprì fino ai fianchi.
Quel numero di ginnastica artistica fece sì che dal corpo di Dora esalasse un pieno e forte odore di donna che investì il nostro eroe, sciogliendogli nelle vene un’allegria ansiosa.
Il farmacista uscì con un gran desiderio di mettersi a fischiare. Era soddisfatto, ma non sapeva di che. Lentamente, con cautela, per paura che quello stato d’animo potesse svanire, s’incamminò verso la salita. Dalle case del Borgo, come una nebbiolina magica, si spandeva sulla piazza l’odore di soffritto.
Da quel giorno Giovanni cominciò a frequentare più spesso la casa di Dora. che lo accoglieva senza pronunciare una parola, ma con un sorriso buono e fraterno. Le poche volte che parlava, era come mettere un balsamo su una ferita. Le sue frasi arrivavano alle orecchie del farmacista in forma canora, con la morbidezza incantatrice dell’ipnotizzatore. I suoi rari e brevi discorsi gli sembravano, adesso, traboccanti di significati profondi che celavano elevati sentimenti non chiaramente espressi per modestia o per chissà quali altre nobili ragioni. Ora tutto di lei, anche uno starnuto, era un’esplosione di incantevole grazia. Lui la divertiva raccontando come alcuni suoi clienti storpiavano i nomi delle medicine. E addirittura uno aveva ingoiato supposte credendole pillole e in farmacia si era lamentato di quanto fossero state amare.
Era sempre riuscito bene nel ruolo dell’amico delle donne. Il suo aspetto, che non aveva niente di maschile e niente di femminile, le rassicurava, le affrancava da ogni tipo di competizione.
Parlarono anche del mazzo di fiori. Dora sorrise imbarazzata, e confessò che aveva paura si trattasse del gesto di qualche pericoloso squilibrato. Il nostro farmacista era soddisfatto di quel rapporto. Gli piaceva stare seduto in quella cucina, respirare l’odore della casa, e guardare sulle pareti ai lati del camino, pendere a seccare corone di peperoni, come amuleti di una civiltà antica. Capiva che le sue visite, anche se non necessarie, erano gradite. Non lo disturbava paragonarle, tra sé, all’effetto placebo di un farmaco inutile.
Una sera, era ancora primavera, il farmacista, di ritorno da Zio Glauco, incontrò Dora che teneva abbracciato un cesto di panni bagnati da appendere avanti casa. Allora si avventurò in un gesto spontaneo che lo sorprese: le toccò una mano chiedendo: «Come va?». Mentre pronunciava queste due parole gli scoppiò un’ansia che lo fece vacillare. Lei non rispose. Piegò appena le labbra di lato. Era un sorriso. Poi piegò leggermente il capo, come per dire “me la cavo”. Col cuore in gola Giovanni stava riprendendo ad andar su, quando lei parlò, e disse: «Vieni domani? Preparo i peperoni ripieni». Questa volta fu lui a rispondere affermativamente con un sorriso: non riuscì a parlare. Gli era sembrato di sentire in quel “vieni domani?” un respiro complice, pieno di sottintesi.
Invece di tornare su, verso casa, entrò nel vialetto di Zio Glauco e andò dritto nel giardino dei ciliegi. Il profumo delle acacie era così intenso da dare il capogiro. L’aria era tiepida. Dal giardino iniziava un sentiero alberato, praticato solo da quelli di casa. Più sotto si collegava a una stradina che scendeva al “fossato”: un ruscello attivo solo d’inverno. D’estate si riduceva a piccoli stagni popolati da girini e grilli canterini.
Il buio fitto forniva alla mente di Giovanni le immagini che gli piaceva ricordare. Prima di arrivare alla stradina, a metà del sentiero, la vegetazione si infoltiva e c’era un tratto in cui i rami degli alberi che erano lungo i lati, si intrecciavano in alto a formare una specie di volta. Sicché sembrava di passare per una galleria. La chiamavano “grotta”. Giovanni, al buio, la rivedeva com’era in primavera: macchie di campanule bianche e viola fiancheggiavano l’inizio del percorso che conduceva alla stradina. Più sotto, tappeti di primule, ciclamini e margherite provvedevano ad aggiungere colori. Immettersi in quel viale era come entrare nel quadro di un pittore impressionista. D’estate, quando si soffocava, nella grotta era fresco. Il fruscio delle foglie secche dell’anno prima sotto le scarpe, l’assordante, ipnotico cicalio, misto al cinguettio dei mille uccellini che lì avevano il loro nido, ne facevano un luogo incantato, dove i ragazzi del Borgo liberavano la fantasia per giocare dentro storie fuori del mondo. Quando si voleva fare qualcosa di trasgressivo, si andava alla “grotta”: la trasgressione consisteva nel salire sugli alberi. Cosa che era stata severamente proibita. Andavano a mettere il pane bagnato nei nidi: ognuno aveva il suo da curare. Fu lì che, poco meno di cinquant’anni prima, Giovanni aveva dato un bacio sulla guancia di Dora, così, all’improvviso. Lei forse non se ne era accorta neppure. Lui ci aveva pensato per anni.
Le visite di Giovanni continuarono. Dora mostrava piacere nel riceverle, ma niente di più.
Arrivò l’inverno. Un giorno, il maresciallo, invitato a cena insieme alla moglie Anna, andò a casa di Dora dopo la sua passeggiata serale. Lo si vedeva poco in giro. Alto, magro e dritto come un fuso, aveva conservato l’aspetto gradevole della persona anziana che si mantiene giovane. Con la gente aveva mantenuto il suo tono grave, contegnoso, di quando era in servizio. Ma era capace di sorridere e dire qualche parola di nessuna importanza, ogni tanto. Sua moglie Anna era lì dal primo pomeriggio. I discorsi giravano attorno alla raccolta dei fondi per il nuovo campanile della chiesa. I conti non tornavano. Imbrogli del parroco? Era l’argomento preferito da Anna che, tra l’altro, insisteva nel dire che era stato lui, il parroco, a inviare i fiori. Sul viso di Dora si alternavano incerti sorrisi di cortese e rassegnata sopportazione: lei stimava il parroco, Anna lo odiava, così come lo odiava suo padre, il notaio, che a sua volta era odiato e temuto da tutto il paese.
Quando entrò il maresciallo, nel paiolo appeso al gancio del camino le lenticchie bollivano già da un pezzo. Dora, sulle punte dei piedi era tutta tesa a cercare di prendere la busta del sale dal ripiano più alto della credenza, riusciva solo a toccarla con la punta delle dita, spingendola sempre più all’interno. Il maresciallo le andò in soccorso per cavalleria, si allungò dietro di lei e prese la busta del sale. Questo trambusto creò un profondo turbamento alla fragile, indifesa anima di Dora: per un attimo il maresciallo, senza alcuna intenzione, aveva avuto contatto col fondo schiena di Dora. Fu solo un attimo, eppure Dora quella notte dormì poco, incerta se il maresciallo aveva peccato innocentemente o con premeditazione. E per tutta la serata non lo guardò mai, e le sue guance si mantennero rosee, come quando gareggiava ai tempi delle scuole medie.
Così, mentre aumentava il numero delle visite di Giovanni, nel petto di Dora cresceva una ansiosa turbolenza per l’episodio del maresciallo. Doveva parlarne con qualcuno. E una mattina, a mezzo della fornaia che era passata per la consueta consegna del pane, Dora inviò un biglietto al farmacista: Ho scoperto chi mi ha inviato i fiori. Ti aspetto stasera. Giovanni si sentì smascherato e, per giunta, interpretò quel “ti aspetto stasera” come una dichiarazione d’amore. Lo assalì l’ansia. Come avrebbe dovuto comportarsi? Le sue esperienze amorose provenivano esclusivamente dai film che raccontava Zio Glauco.
Prese dall’armadio la giacca ancora un po’ odorosa di naftalina.
L’aveva riposta a primavera. Mise le mani in tasca, e mentre scendeva giù per la strada di Tarcisio, avvolto da quel nuovo calore, avvertì una leggera euforia, una rinnovata disposizione all’amicizia, a una nuova intesa col mondo intero. Profumava di lavanda. Era passato dal barbiere che gli aveva anche tagliato i capelli. Pensò al suo amico Antonio. Sapeva che aveva la sua approvazione. Lui stesso gli aveva raccomandato di “non lasciarla sola come un cane”: le sue parole.
Dalla casa di Tullio usciva un rassicurante profumo di caldarroste.
Mentre bussava alla porta di Dora, Giovanni temeva che le sue orecchie prendessero fuoco. Cercava di respingere la sgradevole sensazione di sentirsi nella veste dell’invitato, e non dello sposo. Dora scostò la sedia per invitarlo a sedere. Sul tavolo, evitando di guardarlo, posò il vassoio delle nevole e la solita bottiglia di Anisetta. Tutto avvenne senza il minimo rumore e nel più assoluto silenzio di entrambi. Lei non indossava la tuta da metalmeccanico, ma aveva sul capo il fazzoletto che la faceva somigliare a una contadina.
All’improvviso Dora gli disse che era stato il maresciallo a inviarle i fiori. Ne era certa. Giovanni rimase senza fiato, con mezza nevola in bocca, immobile. Dora continuò a parlare. Giovanni capiva una parola su dieci. Sentì: «È incredibile… Il marito della mia migliore amica… non ho il coraggio di guardarla…».Eppure, anche se stordito da quel rimbombo di vocali e di consonanti che gli raschiavano in testa, riusciva a intravedere con estrema chiarezza che stava accadendo quello che aveva temuto, e per questo mantenuto ben nascosto negli strati più profondi del suo cervello. Dora mai avrebbe potuto innamorarsi di lui. Altre volte aveva vissuto, in forme diverse, la stessa umiliazione, la stessa angoscia. E come le altre volte, avrebbe voluto nascondersi, scappare, per non farsi raggiungere da quella brutta storia.
Sull’uscio, prima di chiudere la porta, Dora lo pregò di tornare a trovarla perché più che mai ora aveva bisogno del sostegno di un amico sincero e leale. Giovanni, solo, in mezzo alla piazza, non capiva se doveva andare su o giù. In quel momento apparve davanti a lui la faccia di Alfredo, il calzolaio, che lo salutava prendendogli le mani con entrambe le sue, quasi volesse baciarle, e gli parlava mantenendole sul proprio petto, come se avesse voluto trattenere qualcosa di suo. Gli parlò dell’amicizia che aveva con suo padre, che benediceva per aver generato un figlio così buono e intelligente. E infine, soffiandogli sul viso il suo alito cipollino, gli chiese di dare un’occhiata alla moglie che era ammalata. E lo trascinò con sé tenendolo per le mani. Giovanni non capiva niente, non parlava, si trovò dentro la camera da letto dove giaceva la moglie di Alfredo che sembrava morta. Tanto che proprio quando aprì gli occhi, Giovanni ebbe un sussulto e prese coscienza di ciò che aveva avanti. In seguito ricordò di aver consigliato di bere vino bollito per la tosse e ingoiare subito due compresse di aspirina.
Alfredo gli mostrò una foto gialla e mangiucchiata ai bordi dai tarli. Era piena di puntini neri lasciati dalle mosche: «Adesso siamo vecchi, con la pelle appesa, ma da giovani eravamo diversi». Era la foto del suo matrimonio. «Vedete? Mia moglie era un fiore. E l’ho trattata sempre come un fiore perché per me, dottore, è come se tutti questi anni non fossero passati. Abbiamo avuto sette figli. Tutti sistemati, ma lontani. Siamo rimasti soli. Non importa. Ci vogliamo bene.» E dopo un po’: «Allora non è grave?».
«No, starete insieme ancora tanti anni.»
«Sia benedetta la signora vostra madre che vi ha generato. Sia benedetta.» E gli baciò le mani.
Uscì da quella casa più cosciente di quanto accaduto in casa di Dora. Era spossato, con appena le forze per camminare. Ma era già rientrato nella sua vita, con la quale, anche se infernale, aveva più dimestichezza.
Si avvicinò alla fontana. Dal centro della piazza si poteva guardare nelle cucine: il cuore di ogni casa. Era ora di cena. Oltre le tendine delle finestre illuminate, si muovevano ombre anonime. Erano le famiglie. Rumori di piatti, di sedie spostate, voci, scoppi di risa: in quelle case la vita cantava la sua canzone. A Giovanni era vietato l’accesso a quella meravigliosa giostra umana. Cominciò ad andare su, lentamente, curvo, come portasse sulle spalle tutto il peso dell’inutilità della sua esistenza. Si voltò a guardare la piazzetta. Era lì che da piccolo aveva giocato al dottore, a campana, a nascondino e a rincorrersi in continuazione. Per i ragazzi del Borgo rincorrersi era stato un moto perpetuo. A quei tempi il Borgo era sempre in festa, pieno di vita. D’estate, nel tardo pomeriggio, quando il sole aveva cessato di bruciare, insieme ai giochi dei ragazzi, iniziava il viavai delle galline, papere e altri animali da casa, che a spola tra le stalle e le abitazioni, vagavano senza meta, come distratti e indecisi turisti in una brulicante via cittadina, inondando la piazza acciottolata, nella luce porpora della sera. Quando poi faceva buio, come in un paesino fatato, appariva dalle finestrelle un pallido lucore da lume a carburo, a testimoniare una vita parca e intima. Il cuore del Borgo era la sua piazza, che da piccolo gli sembrava più grande, vasta e magnifica. Attorno alla fontana gravitava la vita del Borgo. Mentre si aspettava che la conca ramata si riempisse d’acqua, le più banali notizie del paese si traducevano in colorito pettegolezzo, e l’innamorato poteva scambiare parole mozze e furtive con la sua innamorata, che intanto a casa aveva vuotato la conca per procurarsi l’alibi di tornare alla fontana.
Il nostro eroe trasse un sospiro. Non aveva più forze. Sedette sul davanzale di una finestra chiusa, a pianterreno. Nella casa di Tullio qualcuno raccontava una storiella spiritosa. Prima di riprendere a salire guardò indietro ancora una volta. I suoi occhi rividero tutti i suoi compagni di giochi, uno per uno, sgambettare attorno alla fontana. “La felicità ti appartiene fino a quando hai voglia di correre”, pensò.
E gli sembrò di rivedere anche un pallone di pezza, che ruzzolando per la piazza si portava appresso frotte di bambini che cinguettavano urla isteriche, come stormi di rondini in primavera.
. . .
Giovanni Bucci (Alanno, 1944) è uno street photographer che ha fatto propria la frase di Willy Ronis: “Je n’ai jamais poursuivi l’insolite, le jamais vu, l’extraordinaire, mais bien ce qu’il y a de plus typique dansnotre existence quotidienne, dans quelque lieu que je me trouve… Quêtesincère et passionnée des modestes beautés de la vie ordinaire”. Bucci è autore di tre libri di fotografia e scrive per il teatro. Tra i suoi testi di narrativa Il treno per Yelets (2010) e Compra anche le cipolle (2019).