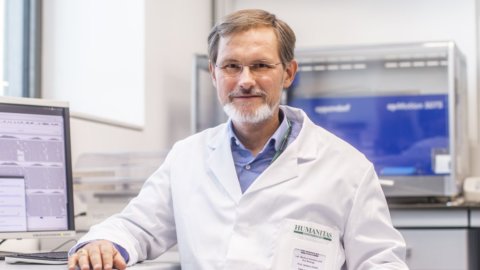Gli italiani sono davvero più esposti al Covid-19 per motivi genetici? Ed è vero che gli uomini sono più vulnerabili delle donne? E l’analisi delle differenze genetiche come potrà aiutare nelle cure e nella prevenzione? Per rispondere a queste domande abbiamo chiesto direttamente al Professor Stefano Duga, ordinario di Biologia Molecolare di Humanitas University, che sta conducendo insieme ad altri ricercatori uno studio volto a comprendere i fattori genetici che influenzano la suscettibilità all’infezione, la gravità del decorso clinico della malattia e anche la maggiore severità dei sintomi che si osservano negli uomini rispetto alle donne: “Una prima analisi, effettuata sul campione dell’intera popolazione e concentrandoci su due proteine di membrana, chiamate ACE2 e TMPRSS2, che fanno da recettori per l’ingresso del virus nelle cellule, ha effettivamente messo in luce varianti genetiche tra la popolazione italiana e quella cinese, e anche quella europea. Ora però stiamo studiando tutto il genoma, analizzando i dati dei pazienti ricoverati in questi mesi nel nostro ospedale, in collaborazione con Policlinico di Milano e l’Università Milano Bicocca. I risultati arriveranno tra qualche settimana”.
Professore, dunque non possiamo ancora dire che gli italiani abbiano un genoma che li mette più a rischio rispetto al Covid-19?
“No. Per ora sappiamo, da sempre, che le differenze genetiche tra individui influenzano la suscettibilità nei confronti di una patologia o la gravità dei sintomi a seconda delle persone. E’ stato così anche per la Sars e la Mers, le due precedenti epidemie da coronavirus. Di certo però i risultati delle nostre ricerche saranno importanti per due aspetti”.
Quali?
“Intanto per individuare, attraverso il Dna, i pazienti più a rischio. Finora il virus ci ha colti di sorpresa e non abbiamo potuto prevederne la gravità e i soggetti più a rischio, se non genericamente quelli di età avanzata e con patologie pregresse. Approfondendo il nesso genetico saremo in grado di stratificare i pazienti e di organizzare meglio l’assistenza sanitaria. E poi per quanto riguarda le cure, in attesa del vaccino sarà decisivo individuare dei target per poter sfruttare le caratteristiche di farmaci già esistenti e usati per altre patologie”.
I vostri studi serviranno anche nella corsa al vaccino?
“Il vaccino consiste nell’indurre una risposta immunitaria, in particolare contro le proteine di superficie del virus, le cosiddette spike. Le informazioni sulle proteine che si trovano alla superficie del virus le abbiamo già, la sequenza del genoma del virus è nota da mesi, ora il problema è trovare un vaccino efficace. Ci vorrà però del tempo, credo un anno e mezzo almeno, anche perché le proteine di superficie del virus, quelle che servono per penetrare nelle nostre cellule, sono ricche di zuccheri e questo rende più difficile ottenere degli anticorpi in grado di legarle specificamente”.
Tornando alla genetica, è quindi vero che gli uomini sono più a rischio delle donne? All’inizio sembrava così, poi i dati dei contagi hanno evidenziato un sorpasso delle donne.
“E’ vero, adesso le donne contagiate sono leggermente di più, ma gli individui di sesso maschile continuano a registrare sintomi più gravi e una mortalità mediamente doppia rispetto a quelli di sesso femminile. Questo vale in quasi tutti i Paesi del mondo, tranne l’India, l’Iran e il Pakistan, per motivi che potrebbero avere più a che fare con le abitudini sociali di quei paesi. In generale, le donne si ammalano meno gravemente perché hanno un sistema immunitario notoriamente diverso e più resiliente di quello degli uomini. Inoltre un ruolo importante potrebbe essere svolto dagli ormoni androgeni. Infatti da nostri studi molto recenti risulta che i pazienti che assumono farmaci contro la iperplasia prostatica, una patologia molto diffusa oltre una certa età, sono risultati meno suscettibili alle forme più gravi di malattia da SARS-CoV-2. Questo verosimilmente perché i farmaci usati per combatterla riducono la stimolazione androgenica”.
Che quindi potrebbe essere considerato anche per prevenire il virus tra gli uomini?
“In Svizzera lo stanno testando anche preventivamente, si tratta per ora sono di sperimentazioni preliminari, ma non escludo che possano essere utili a livello terapeutico. Non va dimenticato che un altro fattore che espone maggiormente gli uomini è la comorbilità e cioè la coesistenza di più patologie diverse in uno stesso individuo. La comorbilità principale nel caso del Covid-19, più ancora dei tumori, sono le malattie cardiovascolari, che colpiscono più frequentemente la popolazione maschile”.
I risultati dei vostri studi potrebbero essere utili anche in una ipotetica Fase 3, per le cosiddette “patenti di immunità”?
“No, anche perché le differenze genetiche più che sulla probabilità di essere contagiati sembrano incidere sulla probabilità di andare incontro ad una forma grave della malattia. I nostri studi saranno dunque utili per organizzare in modo più efficace l’assistenza alle categorie più fragili di pazienti e per trovare nuovi bersagli terapeutici, ovvero nuovi farmaci”.
Il virus ha dimostrato di essere molto persistente e di sapersi “nascondere” nelle nostre cellule: molti pazienti sono asintomatici e ci sono anche i casi di pazienti guariti che risultano prima negativi e poi di nuovo positivi al tampone. Come dobbiamo spiegarcelo?
“Questo meccanismo capita anche con altri virus: sono capaci di rimanere quiescenti nel nostro organismo per un certo tempo, e poi riattivarsi. Abbiamo visto che ci sono tanti contagiati che non sono abbastanza infetti da risultare positivi al tampone. Sono loro, gli asintomatici, i più pericolosi nell’ottica di contenimento del contagio, in quanto difficilissimi da individuare. Per questo, insieme ai test sierologici, è importante continuare a effettuare i tamponi per la ricerca del virus. In Corea del Sud i controlli a tappeto hanno funzionato, ma anche i dati di Vo’ Euganeo, uno dei primi focolai italiani, ci hanno detto che il 40% dei pazienti non presentava sintomi”.
Erano così anche gli altri coronavirus?
“No, la Sars era più grave ma non c’erano casi asintomatici, e dunque bastava monitorare gli individui con sintomi. La Mers era ancora più letale ma anch’essa poco contagiosa. Il Sars-CoV-2 rispetto a queste due è meno letale ma molto più contagioso”.
Che idea si è fatto di quello che accadrà nei prossimi mesi?
“Per il vaccino come dicevo ci vorrà tempo. E’ vero che c’è fretta, ma ci sono dei passaggi necessari da rispettare. Questo è un virus che conosciamo ancora poco, lo stiamo scoprendo adesso. Non mi sorprenderebbe una piccola risalita dei contagi tra qualche tempo”.