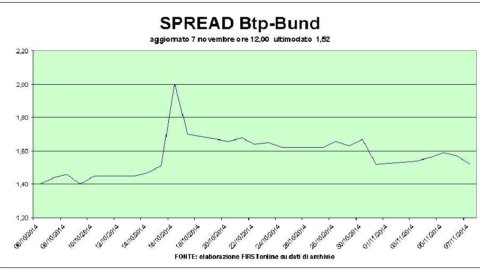Non so dirvi come questa storia sia cominciata, proprio non ricordo come ci sono finito dentro. Ma forse non ha nemmeno importanza, perché i preamboli spesso sono inutili e servono solo a guadagnare tempo. Quello che interessa davvero è il succo, il prezioso distillato che si ricava quando si elimina tutto quello che fa da contorno, poche gocce che se le vedi raccolte tra due mani ti viene da pensare a quanto poco ci rimane della vita una volta che hai tolto i grumi e scremato e filtrato e roba così, insomma mica ci rimane tanto se levi il superfluo. Per farla breve, siamo giunti al momento in cui si fa strada sul volto quell’espressione ebete che compare meccanica, senza controllo, mentre guardi un film e ti dici “ecco, ora sì che è successo qualcosa”. Sono intrappolato in un megastore di elettronica da giorni, non so neanche quanti, e ci sono soltanto io. Ora, la notizia non è poi sconvolgente se si pensa a quelli che restano chiusi in una miniera per mesi e magari ci muoiono disidratati, affamati, assiderati, e non lo è nemmeno rispetto a quelli che finiscono per sbaglio in un pozzo stretto e lungo e buio mentre camminano tranquilli in un sentiero di campagna e crac!, una tavola di legno marcio sotto i loro piedi si rompe e li fa rovinare giù, nell’abisso, a pochi metri dal mondo ma abbastanza lontani da qualcuno che possa soccorrerli. La cronaca nera del telegiornale con me non c’entra niente. Io qui per adesso ho da mangiare e da bere (ci sono due distributori automatici di snack, bibite, caffè) e pure la temperatura non è malaccio (e poi, con tutti gli elettrodomestici che ci sono, volete che manchi un climatizzatore?). La notizia sconvolgente è un’altra, tenetevi forte: ieri, preso da un momento di disperazione per il fatto di essere imprigionato qui, me ne stavo rannicchiato a lagnarmi in un angolo, nel reparto CD, e chi ti incontro? Elvis. Dico lui, Elvis Presley, il Re, capito? Lui che porta fiero il suo ciuffo a banana e i suoi folti basettoni (che diavolo, ma lui era Elvis del resto) ed è vestito col suo classico completo bianco, lustrini, paillettes, maniche sfrangiate, stivaletti, quel portamento, quell’andatura, imbraccia la chitarra come fosse una donna, era lui dalla testa ai piedi, lui che verrebbe riconosciuto da uno zulu sudafricano come da un abitante del Borneo. Si avvicina e mi parla nella mia lingua, e scandisce anche bene le parole (cazzo ne so perché parlava l’italiano, non chiedetemelo ma era così).
«Amico, non piangere» mi dice.
E chi piange più, c’è Elvis davanti a me.
Lui poggia delicato le dita sulle corde e inizia a cantarmi Are You Lonesome Tonight con quella sua voce, che perdio forse non sarà la più bella mai sentita secondo le classifiche degli esperti ma a me è sempre sembrata unica, impossibile da riprodurre, qualcosa di inspiegabile, quasi celestiale, qualcosa che se la senti rimani lì incollato ad ascoltare immobile perché non c’è nient’altro che in quegli istanti possa interessarti di più.
Io muovo la testa seguendo la canzone, testa che oscilla qua e là, sembro uno scemo, gli occhi chiusi e un sorrisetto da teenager innamorato (mancano solo i cuoricini intorno, che si elevano e scoppiettano come popcorn), mi pare anche di sentire i coretti in sottofondo. Mi immagino passeggiate romantiche e mani incrociate e baci: baci sulla guancia (smack!); baci a stampo (schiok!); baci con la lingua (sguish sguish!); baci senza lingua (uff!); baci memorabili (wow!); baci da dimenticare (reset!); baci rubati (ne-ni ne-ni ne-ni!); baci inseguiti (brooooom!); baci richiesti (kiss?); baci mai avuti (fuck!); baci perduti (no!); baci ritrovati (oh yeah!); baci durati pochi secondi (bye bye!); baci che non finiscono più (do not disturb, please…).
Fine dei baci. E poi tutte le pomiciate che mi sono fatto negli anni da ragazzo, uomo, adulto, quelle che farò, magari non da vecchio ma finché potrò sì, ecco, tutte le pomiciate e quella canzone come colonna sonora. Poi finisce e io apro gli occhi, ma Elvis non c’è più.
«Elvis! Elvis!! Elvis!!!» [Nota dell’autore: aumento progressivamente i punti esclamativi così da dare più enfasi.]
Comincio a cercarlo dappertutto ma lui è svanito, andato… L’ho visto davvero, era una visione, un’apparizione tipo quelle dei ferventi religiosi, cos’era? Faccio il giro del megastore e ritorno nel punto in cui l’ho visto, poi neanche il tempo di snocciolare qualche ipotesi (ipotesi 1: ho le allucinazioni, sono pazzo; ipotesi 2: Elvis appare solo agli eletti; ipotesi 3: si tratta di un sogno e tutto questo non è mai successo; ipotesi 4: magari si è staccato un pannello dal soffitto o un cavo elettrico, è caduto e boom!, mi ha colpito dritto in testa, così ora vivo una di quelle strane esperienze tra la vita e la morte; ipotesi 5: stanno scrivendo un racconto su di me, oppure stanno scrivendo su uno che sta scrivendo un racconto su di me; e via dicendo, ipotesi su storie troppo assurde per essere vere, come dimensioni parallele e trame adatte a film onirici, visionari, alla David Lynch, per intenderci) e nel reparto CD vedo qualcun altro, dico “qualcun altro” ma invece è Frank Sinatra in persona, eh sì, non mi sbaglio, The Voice, Ol’ Blue Eyes, Frankie, chiamatelo come vi pare, è proprio lui [Nota dell’autore: ometto consapevolmente il soprannome Swoonatra, in Italia non è mai suonato tanto bene]. Mi guarda, mi fa l’occhiolino e mi dice “vieni con me” (anche lui con un italiano perfetto. Va be’, ma era di origini italiane oppure avrà fatto un corso di lingua insieme a Elvis).
Io lo seguo, e come si fa a non seguire Frank Sinatra, solo a vederlo camminare vorrei chiedergli delle ripetizioni di carisma. Inizia a canterellare Come fly with me a cappella e io sono già in estasi. Arriviamo nel reparto poltrone elettriche, lui mi fa cenno di sedermi e sta per un attimo in silenzio. Io reclino lo schienale fino a trovare la posizione e mi metto comodo (mica male queste poltrone, hanno pure l’effetto vibro!), lui intanto batte il piede per dare il ritmo. Vedo comparire per magia un microfono tra le sue mani – eppure è strano, sono sicuro che prima non ce l’avesse – parte la musica, la tromba il pianoforte il contrabbasso e tutto il resto, lui che schiocca le dita a tempo, di nuovo Come Fly with Me ma stavolta è suonata come a un concerto, è un live solo per me, e ancora la testa che si muove, oscilla qua e là, io come uno scemo e gli occhi chiusi e il sorrisetto, volo sopra il megastore, lo sorpasso, ancora più su, sempre più veloce, è giorno, sbuco da una nuvola e puff!. Comincia a far freddo, è buio, buio pesto, un buio mai visto [Nota dello psichiatra: ossimoro fortemente voluto dall’autore!], sono nello spazio, lo spazio sconfinato, pianeti, stelle, satelliti vaganti, shuttle, il sole, la luna, la terra – vedo una scimmia battere su un cumulo d’ossa laggiù, sulle note di Così parlò Zarathustra di Strauss – luci abbaglianti, spettro di colori viola-giallo-verde-rosso-blu, un feto astrale e poi il monolito nero che spunta, viene verso di me, si avvicina, mi sta per schiacciare, ma no, sono io il monolito, sono io, li schiaccio tutti (ma a che mi serve essere così grande e imponente se tanto sono solo?). Poi ci ripenso e ricomincio a scendere, non sono più il monolito, mi allontano, fiondo giù come una scheggia, una palla di fuoco, esco dal buio, esco dal freddo, buco la nuvola e ancora puff!, di nuovo giorno, giù fino a tornare al megastore, eccolo, lo vedo, rientro all’interno, il sorrisetto, gli occhi chiusi, io come uno scemo, la testa che si muove, oscilla qua e là, gli occhi aperti: la musica non c’è più, Frank Sinatra non c’è più!
«Frank! Frank!! Frank!!!» [Nota dell’autore: ribadisco il concetto dei punti esclamativi, e poi devo dare continuità alle mie scelte stilistiche.]
Mi ha abbandonato anche lui e io mi chiedo perché le cose belle durino sempre troppo poco [Nota dell’autore: momento di crisi creativa, gioco il jolly], ma poi sento parlottare, c’è qualcun altro, là, nel reparto dvd, eccoli, mi avvicino e li vedo bene, sono in quattro: ci sono Orson Welles, Alfred Hitchcock, Billy Wilder e Stanley Kubrick che discutono tra di loro. Faccio per andargli incontro ma subito qualcosa mi blocca, anzi qualcuno, mi tira per un braccio, io mi giro, lo vedo, oh-mio-Dio! (messaggio privato all’ex catechista: no, mi dispiace, non sono credente, ma questa espressione rendeva bene l’idea], mai avrei immaginato di incontrarlo qui, Humphrey Bogart! Bogie è vestito come in Casablanca, col suo impermeabile e il cappello con la fascetta, e poi quella sigaretta fumante tra le dita. Ma perché lo vedo in bianco e nero? Non lo so, però queste tonalità gli donano molto; anzi, è l’unica volta in cui penso che i colori nel cinema siano superflui!
«Che vuoi fare, ragazzo?» mi chiede lui, incurvando un po’ un sopracciglio (se vi state chiedendo se parlava italiano anche lui, sì, la risposta è affermativa. E che voce!).
«Che voglio fare? Là, a pochi passi da me, ci sono i più grandi registi della storia del cinema. Adesso vado da loro e ci scambio due chiacchiere, mi sembra il minimo.»
«Non scappano mica, sai?» ribatte lui, ridacchiando.
«Ah no? E come la metti con Elvis e Frank Sinatra? Stavano lì e dopo un attimo non c’erano più.»
«Svegliati, ragazzo» mi fa Bogart, ritornando serio.
Noto che la sua sigaretta non si consuma mai. Lui continua a fumare e quella rimane sempre uguale. Ma che diavoleria è mai questa? Mi balena in mente che forse si tratta di un trucco cinematografico, poi torno a fissarlo in faccia. «Vuoi dire svegliati nel senso che sto dormendo? Insomma, tra poco mi sveglierò nel mio letto e tutto si rivelerà banalmente un sogno?»
«Ehi, ragazzo, questo l’hanno già fatto. Non hai mai visto Il mago di Oz?»
«Hai ragione, non può essere così. Sarebbe fin troppo scontato, no? Allora cos’è che intendevi?»
«Tu puoi vedere chi vuoi e quando vuoi, qua dentro.»
Io lo guardo, ancora più confuso di prima. Così lui prosegue.
«Per esempio, guarda là, nella sezione libri. Vedi quello?»
Compare un tizio, capelli neri con divisa da una parte che arrivano di poco fin sotto alle orecchie, e baffi che gli danno una certa importanza. Indossa un completo scuro con cravattino sopra una camicia bianca. Sta sfogliando avidamente dei volumi.
«E quello chi è?» chiedo io.
«Edgar Allan Poe, chi vuoi che sia» chiarisce lui, pure un po’ scocciato.
Io faccio per andare anche stavolta, ma Bogie mi prende di nuovo per il braccio.
«Forse non ci senti bene, ragazzo. Lascia stare Poe, oggi è pure ombroso. Credo che abbia bevuto più del solito.»
«Ma forse non ci saranno altre occasioni» piagnucolo io.
«Ce ne saranno molte altre, invece. Ti ripeto: tu puoi vedere chi vuoi e quando vuoi. Se vuoi vedere Conan Doyle, tu puoi vederlo. Se vuoi vedere Dostoevskij o Kafka, puoi vedere anche loro.»
«D’accordo.»
Finalmente mi rassegno.
«Una domanda, ragazzo: in che anno siamo?»
«Beh, quando sono entrato qui era il 2011, ma adesso non so. Ecco, potrebbe essere il 2012, come il 2015 o qualsiasi altro anno.»
«Ne avete inventate di cose, dai miei tempi, eh?» mi fa lui, dandosi un’occhiata attorno.
«Già.»
«E dimmi, ragazzo, per caso avete inventato anche una macchinetta che conta tutti i soldi che uno ha buttato nella sua vita? Voglio dire, quelli che uno ha sprecato, che ha speso inutilmente. Ho sempre pensato che qualcosa del genere, nel futuro, potesse servire.»
«No, questa non l’abbiamo inventata» gli rispondo, mentre ripenso a tutti i soldi che ho buttato io e alla genialità di un simile marchingegno.
«Peccato… Allora il futuro non dev’essere un granché.»
«Già» annuisco ancora.
«Come ti chiami, ragazzo?»
Io rimango spaesato, come se mai nessuno mi avesse fatto quella domanda. Come mi chiamo? Qual è il mio dannato nome?
«Non lo so» rispondo con candida amarezza.
«Posso chiamarti Louis?»
«Certo, tu puoi chiamarmi come ti pare.»
Ci penso un po’ su. In effetti Louis non mi dispiace.
«Louis, forse oggi noi inauguriamo una bella amicizia.»
Ripenso a queste parole, sono sicuro di averle già sentite. Non ricordo dove né quando, però. So solo che mentre sto lì a pensare, compare una nebbiolina che si fa sempre più fitta e si alza fino a catturare Humphrey Bogart e a portarlo via con sé. Bogie sparisce in mezzo alla fottuta nebbia, anche lui mi lascia.
«Humphrey!!!!!!» [Nota dell’autore: non mi tornava mica tanto bene ripetere il suo nome per tre volte. Non risparmio però sul numero complessivo di punti interrogativi.]
Ma che avrà voluto dire alludendo ad altre occasioni? Che significa, che marcirò qui a lungo?
Arriva la notte ed è come se lo sconforto più cupo e opprimente dividesse il letto con me (ma quale letto? Al massimo una poltrona elettrica), lo sconforto che è un corpo sfatto e ingombrante, e sotto c’è un abisso senza fondo, e sopra un cielo nero e smisurato senza speranza. Penso e ricordo. Ripenso e ricordo ancora. Ricordo, soprattutto ricordo. Ricordo che questo genere di negozio era il mio preferito, ricordo l’ultimo concerto del Boss e le sue tre ore no-stop, ricordo Brazil di Terry Gilliam, ricordo tutti quelli che mi incontrano per la strada dopo un po’ di tempo e mi chiedono come mai sono sempre così magro e forse anche più magro di prima (ma io ho il metabolismo veloce, eccheccazzo, ancora non l’avete capito?), ricordo birre bevute, birre con gli amici e birre solitarie, birre chiare birre scure birre, rosse birre ad alta e bassa fermentazione, birre al luppolo, birre al frumento, birre al malto d’orzo, birre doppio malto, birre ambrate, birre weiss, birre schiumose, birre senza schiuma, ricordo discoteche che non mi piacevano e discoteche che odiavo (ma perché allora ci andavo?), ricordo quella compagna di classe alle superiori che voleva in tutti i modi venire a letto con me e io no perché ero fissato con un’altra con cui stavo che poi mi lasciò senza farmela neanche vedere da lontano [Nota del censore: si intuisce il senso, non c’è bisogno di usare quella parola che inizia per “f”], ricordo il ciuffo improponibile che portavo negli anni Novanta (per forza, guardavo sempre Beverly Hills 90210), ricordo l’ondata grunge e quando sembrava che esistesse solo quello, ricordo l’Amiga 500 e Sensible Soccer, ricordo le forche a scuola e la bocciatura (perché stavo sempre a giocare a Sensible Soccer), ricordo la pommarola con le polpette che mia nonna faceva la domenica (che profumo!, mi pare di sentirlo anche adesso), ricordo il Commodore 64 e i giochi in cassetta, ricordo il Subbuteo e le partite con mio zio che quando vinceva mi sfotteva sempre, ricordo la pubblicità della Cola-Cola con le fiammelle degli accendini [Nota dell’autore: sono consapevole dell’errore, ma non si sa mai che un colosso del genere mi venga a chiedere di pagargli i diritti per aver citato il nome], ricordo i lunghi assolo di sax come intermezzo strumentale nei pezzi di rock leggero anni Ottanta, ricordo viaggi in auto sul sedile posteriore e come colonna sonora Pooh-Dalla-Venditti (quante volte poi mi sono trovato a riascoltarli in preda alla nostalgia!), ricordo i calzoncini corti e i calzettoni fino alle ginocchia e le scarpine blu a occhi di bue e la giacchettina che buttavo sempre sull’erba e i riccioli biondi che non ci sono più, ricordo E.T. al cinema da piccolo e poi non ricordo più niente. Non ricordo più come mi chiamo né come sono finito qui. Poi ecco che ricomincio a pensare, penso a una cosa sola, ciò a cui non si dovrebbe pensare in una situazione del genere ma vai a spiegarlo a uno disperato: la morte. Magari Bogart intendeva dire che ci ritroveremo tutti dall’altra parte e allora sì che ci saranno tante occasioni di rivedersi: io morto, lui morto, tutti morti. Me lo domando di nuovo, cento e mille volte: morirò? Ripenso. Certo che morirò. Ma morirò in questo megastore? Morirò senza aver mai visto La Grande-Jatte di Seurat all’Art Institute di Chicago e il Félix Fénéon di Signac al MoMA di New York (e va bene, mi piace il movimento puntinista!), morirò senza essere mai stato né in Giappone né in Australia, morirò senza aver imparato bene l’inglese (dico bene nel senso che poi deve corrispondere al livello di conoscenza reale indicato nel mio curriculum) e a suonare uno strumento che sia uno (i piatti e il triangolo non valgono, però), morirò senza aver finito di leggere Alla ricerca del tempo perduto di Proust che sta lì sul mio comodino da parecchio e qui non ce n’è una copia! [Nota dell’autore: in realtà sul mio comodino c’è una raccolta di racconti di Woody Allen, ma il mio personaggio fa letture più impegnate], ma soprattutto morirò senza aver mai pronunciato parole come protervo, ubertoso, occiduo, dagherrotipico, sinallagmatico in un discorso pubblico o termini d’altri tempi come giammai, testé, fellone con i conoscenti, solo per mostrare la mia saccenteria (lo so, è brutto, ma si dice così, e non “saccenza”. Approfitto per proporre petizione riguardante la sostituzione dei due termini nel vocabolario della lingua italiana)! E allora comincio a urlare quelle parole come fossero una sola, senza prendere fiato, e vien fuori una specie di cantilena (e la cosa più bella è che il numero complessivo di lettere batte ampiamente il supercalifragilistichespiralidoso di Mary Poppins!):
PROTERVOUBERTOSOCCIDUODAGHERROTIPICOSINALLAGMATICOGIAMMAITESTÉFELLONE!!!
Succede qualcosa. Penso che se riesco a dire una cosa del genere tutta di fila e senza mai prendere fiato allora posso riuscire a fare tutto. E mentre sto ancora lì a pensarci, mi appare davanti agli occhi una scritta gigantesca, caratteri cubitali che lampeggiano: CHI SE NE FREGA (questa non sono sicuro di averla vista davvero, ma se l’ho vista mi è comparsa su uno schermo piatto da 60 pollici, colori vividi e alta risoluzione dell’immagine). Chi se ne frega se marcirò qua dentro, chi se ne frega se morirò, chi se ne frega se non vedrò o non farò qualcosa. Sono qui e posso vedere chi mi pare e quando mi pare (oh, me l’ha detto Humphrey Bogart, mica me lo sono inventato). Proprio quando realizzo questo, sento una musica salire pian piano di volume. Mi avvicino al reparto impianti hi-fi e amplificazione e vedo che hanno montato un palchetto sopra al quale si esibisce una band e… e…. oh-mio-Dio! (ribadisco all’ex catechista che faccio un uso improprio di questa espressione), è il supergruppo rock che ho sempre sognato: Jimi Hendrix alla chitarra, Jaco Pastorius al basso (se non lo conoscete, andate subito a vedere quello che sapeva fare!), Keith Moon alla batteria e Freddy Mercury alla voce (il posto alla tastiera rimane vacante perché i tastieristi che mi piacciono sono ancora tutti vivi!). Freddy (che è vestito come al concerto di Wembley del 1986: tuta bianca con strisce rosse, canottiera bianca pure quella e giubbottino giallo) mi guarda e mi fa cenno col dito di sedermi in prima fila (c’è solo la prima fila, comunque). Quando mi accomodo, lui va al microfono.
«This is for you, guy» mi fa Freddy Mercury (faccio notare che lui non parla italiano, al contrario degli altri. Evviva l’anticonformismo!), e poi continua: «A megastore Odyssey».
Una canzone nuova, scritta apposta per me. Ed ecco la sua voce e lui che prende a muoversi (uh, come si muove Freddy!) e Jimi Hendrix e Jaco Pastorius che fanno cose da pazzi coi loro strumenti e Keith Moon che comincia a rullare alla sua maniera. Sono incantato, inebriato, rapito [Nota dell’autore: sinonimi usati per rafforzare il concetto], la canzone è pure bella; dura minuti e poi ore, ore e ore, tutta la notte, sempre quella, tant’è che mi addormento e mi sveglio al mattino.
Siamo tornati al punto di partenza. Il supergruppo non c’è più, ma ci sono io. Non so dirvi come questa storia sia cominciata né come finirà. D’altra parte, cosa pretendete da uno che non sa dirvi nemmeno come si chiama? Forse non dovrebbero essere sempre aperti negozi come questo, o al massimo osservare un solo giorno di riposo? Ed è possibile che le mie scorte di bibite e alimenti non si esauriscano mai? Ma cos’è davvero importante, in conclusione? Trovare per forza una spiegazione o fregarsene e godersela fino in fondo? Ho deciso che non starò più a chiedermi niente, vivrò così, vedendo chi mi pare e quando mi pare fino a che mi pare. Al diavolo le spiegazioni razionali, casomai ce ne fosse una. Al diavolo anche le lamentele. Dico sul serio, ho cambiato filosofia di vita (messaggio sotto voce: in realtà è stato Humphrey Bogart a convincermi a dire queste cose. È qui, sta accanto a me, in bianco e nero, con la sua infinita sigaretta fumante tra le dita. E giuro, non mi sta puntando addosso una pistola!). Questa è tutta la storia. Adesso vado, ho appuntamento con Oscar Wilde alla sezione libri tra pochi minuti. Sorseggeremo insieme un tè del distributore automatico e lui intanto mi intratterrà con i suoi aforismi. L’unico problema è che mi ha chiesto di vestirmi bene, ma non so come fare perché qua ci sono soltanto magliette di gruppi musicali e quello che ho indosso non va mica tanto bene per un incontro con un dandy come lui. Ma questo è un problema che non vi riguarda, me la vedrò da solo.
«Andiamo, Louis.»
«Sì, Humphrey. Ehm, senti, dato che Elvis non ha niente che faccia al caso mio… non è che mi presteresti impermeabile e cappello, per caso?»
«Neanche morto, Louis. Neanche morto.»
La sigaretta continua a fumare. E il fumo si confonde con la nebbia. Io e Bogart scompariamo là in mezzo.
Mirko Tondi Nato nel 1977, ha ricevuto una menzione speciale al premio Troisi (2005), pubblicato poesie e racconti in volumi antologici (tra cui un racconto per i Gialli Mondadori, 2010), alcuni romanzi che ama definire “sperimentali” senza sapere se sia effettivamente così. Cura laboratori di scrittura a Firenze (dove organizza anche il Circolo Letterario) e Viareggio. La sua ultima pubblicazione, edita Robin, è Vederci doppio (2018).