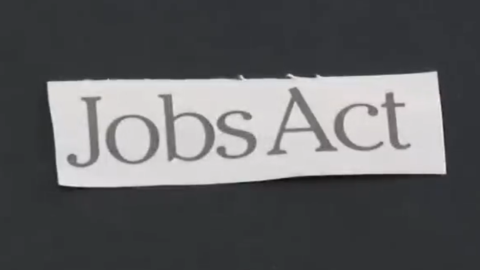L’aggettivo che ricorre più spesso sui media e nei social statunitensi per definire il concentrato di politiche xenofobe, populiste, autoritarie e allineate al suprematismo bianco dell’inizio del secondo mandato di Donald Trump è unprecedented (senza precedenti). L’idea che The Donald stia perseguendo obiettivi inediti, avvalendosi di pratiche sconosciute per il proprio Paese, accomuna da tempo sia gli estimatori del tycoon sia i suoi critici.
I sostenitori del presidente continuano a cavalcare il fenomeno dell’antipolitica, grazie al quale Trump è riuscito a tornare alla Casa Bianca nelle elezioni del 2024, ed esaltano la presunta efficacia del decisionismo di The Donald e la sua capacità di trascendere i comportamenti convenzionali dei predecessori di entrambi i partiti in nome della difesa degli interessi dei cittadini americani. I detrattori, invece, intendono mettere in risalto l’estraneità delle tendenze dispotiche dell’amministrazione Trump rispetto alla tradizione politica democratica e allo stesso carattere nazionale degli Stati Uniti.
Il metro dei primi tre mesi di presidenza
Dall’epoca del democratico Franklin D. Roosevelt, che fu alla guida degli Stati Uniti dal 1933 al 1945, il centesimo giorno dall’inizio del mandato di un presidente, che per Trump è stato il 29 aprile, rappresenta tradizionalmente l’occasione per tracciare un bilancio iniziale dell’amministrazione in carica. Proprio attraverso il confronto tra i primi cento giorni di Trump e quelli di Roosevelt sembra avere buon gioco chi denuncia la novità della deriva illiberale intrapresa dagli Stati Uniti dopo il secondo insediamento del tycoon lo scorso 20 gennaio.
La ragione non consisterebbe soltanto nella contrapposizione tra le iniziative progressiste di Roosevelt e quelle reazionarie di Trump. Il motivo risiederebbe anche e soprattutto in una questione di metodo: mentre i principali programmi del New Deal rooseveltiano per fare uscire gli Stati Uniti dalla depressione economica degli anni Trenta del Novecento furono formalmente varati dal Congresso, convocato in sessione straordinaria dal presidente, nel rispetto della ripartizione delle competenze tra il potere esecutivo e quello legislativo, Trump ha fatto uso in misura smodata di ordini esecutivi. Ne ha emessi ben 139 nei primi cento giorni per aggirare qualsiasi possibile forma di resistenza e di dissenso da parte della Camera e del Senato, nonostante il suo partito abbia la maggioranza in entrambi i rami del Congresso.
The Donald ha pure sostanzialmente eluso la posizione della Camera e del Senato nella diatriba riguardante la proprietà di TikTok perché, per ben due volte, ha concesso a ByteDance, la società cinese che la controlla, una proroga del termine ultimo entro il quale cedere le operazioni della piattaforma negli Stati Uniti a un’azienda americana per non venire messa al bando.
Inoltre, se Roosevelt dovette piegarsi alla volontà della Corte Suprema, che bloccò alcuni suoi provvedimenti, Trump ha ignorato deliberatamente le ingiunzioni del sistema giudiziario, rifiutandosi per esempio di revocare la deportazione nel Salvador di Kilmar Armando Abrego Garcia, un immigrato sposato a una cittadina statunitense, legalmente residente negli Stati Uniti ed espulso per errore per ammissione dello stesso governo. Il tycoon ha persino ricorso all’intimidazione della magistratura, come nel caso dell’arresto della giudice Hannah Dugan, accusata di avere ostacolato la cattura di un immigrato irregolare da parte delle autorità federali.
Lo Alien Enemies Act
Trump aveva già dato dimostrazioni di xenofobia durante il primo mandato con il Muslim Ban, il blocco degli ingressi dei cittadini di alcuni Stati a maggioranza musulmana, deciso con tre diversi ordini esecutivi nel corso del 2017. Inoltre, proprio l’attuale campagna di The Donald contro l’immigrazione clandestina induce a ridimensionare la tesi secondo cui le politiche del tycoon non troverebbero un riscontro nella storia statunitense passata.
Sarebbe sufficiente riflettere sul fatto che lo scorso marzo l’amministrazione Trump ha invocato una legge del 1798, lo Alien Enemies Act, per deportare oltre duecento venezuelani – presunti appartenenti a una gang criminale, la Tren de Aragua – con un provvedimento d’urgenza che non consentiva loro la possibilità di opporsi all’espulsione davanti a un giudice. L’esistenza di questa disposizione, vecchia di oltre due secoli, attesta che, sin quasi dalla loro costituzione in nazione sovrana alla fine del Settecento, gli Stati Uniti non si sono fatti scrupolo di sbarazzarsi di stranieri considerati indesiderabili. All’epoca, costoro erano gli esuli delle diverse fazioni sconfitte nel corso degli sviluppi della rivoluzione francese del 1789 – prima i girondini e poi i giacobini – e i repubblicani in fuga dalla Gran Bretagna monarchica, tutti immigrati ritenuti troppo radicali per la prospettiva conservatrice del partito federalista che era al momento al potere.
La legge fu poi applicata contro i sudditi inglesi durante la seconda guerra che gli Stati Uniti combatterono contro il Regno Unito tra il 1812 e il 1815. Tornò a essere utilizzata contro i cittadini tedeschi e austro-ungarici dopo l’intervento di Washington nella Grande guerra nonché nei confronti di italiani, tedeschi e soprattutto giapponesi durante la seconda guerra mondiale. In particolare, grazie a questo provvedimento, dopo l’attacco subito dagli Stati Uniti a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941, Franklin D. Roosevelt fece rinchiudere in campi di internamento circa 110.000 persone di ascendenza giapponese, su un totale di poco più di 120.000, compresi i figli degli immigrati nati negli Stati Uniti che erano cittadini americani in virtù dello jus soli, con il pretesto che costoro avrebbero potuto operare come una quinta colonna al servizio del nemico qualora le forze armate nipponiche avessero invaso il Paese.
Le espulsioni in tempo di pace
Le deportazioni di massa non sono rimaste confinate alle fasi di coinvolgimento degli Stati Uniti in conflitti bellici. Nel biennio 1919-1920, per il timore che una rivoluzione di stampo bolscevico potesse prendere piede in America, il procuratore generale (l’analogo del ministro della Giustizia di un Paese europeo) A. Mitchell Palmer fece deportare alcune centinaia di anarchici e di socialisti sospettati, nella migliore delle ipotesi in base a prove indiziarie, di voler rovesciare con la forza le istituzioni federali.
Il clima illiberale dell’epoca portò nel 1927 all’esecuzione di due immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, condannati alla sedia elettrica per duplice omicidio, al termine di un lungo e controverso processo pesantemente condizionato da pregiudizi verso gli imputati per il fatto che erano anarchici e di origine italiana.
Altre espulsioni di immigrati radicali, questa volta di orientamento comunista o presunto tale, caratterizzarono gli anni del maccartismo, tra il 1950 e il 1954, all’acme della prima fase della guerra fredda tra Washington e Mosca. A tale proposito, il giornalista Eric Salerno, al tempo appena undicenne, ha rievocato nel libro Rossi a Manhattan (2001) la cacciata dagli Stati Uniti, il 23 novembre 1950 (il giorno del Ringraziamento), di suo padre Michele – che si era trasferitosi in America dalla Calabria ventotto anni prima per sottrarsi alle violenze fasciste – perché figurava tra gli iscritti al partito comunista. A quello stesso periodo risale l’Immigration Nationality Act, una legge del 1952 che, tra le altre disposizioni, autorizzò il segretario di Stato a revocare il visto a stranieri considerati una minaccia per gli Stati Uniti. Settantatré anni dopo, proprio questa clausola è stata utilizzata da Marco Rubio per rimpatriare gli studenti universitari che avrebbero inscenato manifestazioni a favore di Hamas lo scorso autunno.
Più in generale, la pervasività della campagna anticomunista dell’epoca maccartista segnò una limitazione delle libertà individuali, non solo degli immigrati ma anche dei cittadini statunitensi, lo scadimento del dibattito politico a reciproci scambi di accuse, spesso prive di un riscontro probatorio, e l’affermazione di un metodo e di uno spirito da inquisizione che investì anche le università, indotte – come sta tentando di fare oggigiorno l’amministrazione Trump – a mettere a tacere le voci di dissenso espresse sia dai docenti sia dagli studenti.
Altri tipi di allontanamento
In passato, le espulsioni di massa degli immigrati dagli Stati Uniti non sono neppure rimaste limitate a casi di natura politica, riconducibili in qualche maniera alla necessità di tutelare la sicurezza nazionale. Tra il giugno e il settembre del 1954, l’amministrazione del presidente repubblicano Dwight D. Eisenhower deportò o costrinse comunque a rimpatriare oltre un milione di cittadini messicani con l’operazione Wetback (un’espressione dispregiativa che si richiamava alla considerazione che i clandestini avessero la schiena umida perché sarebbero entrati illegalmente negli Stati Uniti guadando il Rio Grande, anziché attraverso i normali posti di frontiera come poteva fare chi era munito di visto).
A determinare il loro allontanamento fu la constatazione che il mercato del lavoro non aveva più bisogno di loro, dopo che la firma dell’armistizio nella guerra di Corea nel 1953 aveva comportato la smobilitazione e il ritorno alla vita civile di gran parte dei militari statunitensi impegnati fino ad allora nei combattimenti. Gli Stati Uniti sono stati anche teatro di deportazioni interne, soprattutto nel caso dei nativi americani, trasferiti forzosamente in massa nei territori dell’Ovest e poi rinchiusi nelle riserve nel corso l’Ottocento. La vicenda più efferata ebbe come protagonisti loro malgrado i Cherokee. La scoperta di oro nella regione della Georgia dove vivevano indusse l’assemblea legislativa di questo Stato a espellerli. Il presidente della Corte Suprema, John Marshall, stabilì nel 1831 che la decisione era incostituzionale. Ma il presidente democratico Andrew Jackson non fece niente per difendere i Cherokee, limitandosi a commentare: “Marshall ha emesso la sua sentenza; ora vediamo se riesce ad applicarla”.
L’indifferenza della Casa Bianca di fronte a un provvedimento della magistratura fu un’anticipazione del rifiuto dell’amministrazione Trump di far tornare Garcia negli Stati Uniti o di ottemperare all’ordinanza del giudice James Boasberg che aveva ingiunto al governo di far rientrare gli aerei che stavano portando nel Salvador i presunti membri della Tren de Aragua.
Gli anni Trenta dell’Ottocento, mentre nel Sud la schiavitù era ancora legale, videro anche un’intensificazione della riduzione dei diritti civili e politici dei pochi afroamericani liberi per spingerli a lasciare gli Stati Uniti, trasferendosi per esempio in Canada, in modo da sottrare energie e aderenti al movimento abolizionista e impedire un qualche indebolimento del potere dell’élite bianca.
Nel decennio successivo, i mormoni furono costretti ad abbandonare gli Stati Uniti e a rifugiarsi nella regione dello Utah, al tempo sotto la sovranità messicana, in seguito a un’ondata di violenze scoppiate in Illinois e culminate con il linciaggio del loro capo religioso, Joseph Smith, nel 1844.
Il modello jacksoniano
Andrew Jackson non fu l’unico presidente a precorrere Trump nel boicottare apertamente le decisioni della magistratura. Nel 1861, all’inizio della guerra civile, il repubblicano Abraham Lincoln mantenne sospeso lo habeas corpus (il diritto di un arrestato a chiedere il vaglio di un giudice sulla legittimità della propria detenzione) sebbene la sentenza della Corte Suprema sul caso Ex parte Merryman glielo avesse esplicitamente vietato. Jackson fu anche il primo presidente a dare prova di decisionismo, rivendicando la definizione di una agenda legislativa autonoma dalla maggioranza del Congresso. Con una manifestazione di protopopulismo, Jackson sfruttò il fatto che la composizione del collegio dei grandi elettori che lo aveva portato alla Casa Bianca nel 1828 non era più designata dalle assemblee legislative dei singoli Stati, come in passato, ma era definita attraverso il voto dei cittadini per attribuire al presidente, al quale erano stati fino ad allora riconosciute scarse prerogative al di là del vago potere di applicare la Costituzione, un mandato popolare in base al quale elaborare un proprio programma di governo.
Sulla base di questo principio si ritenne in diritto di destituire tutti i funzionari federali nominati dai suoi predecessori e di sostituirli con dirigenti a lui fedeli, in modo che la burocrazia non intralciasse l’operato della Casa Bianca. Jackson espresse anche un numero di veti superiore a quello di tutti i suoi predecessori messi insieme ed esercitò questa prerogativa per rifiutarsi di promulgare leggi di cui non condivideva il contenuto politico, anziché limitarsi a bloccare quelle passibili di incostituzionalità.
Nella sua veste di capo delle forze armate minacciò addirittura di occupare militarmente la Carolina del Sud per costringerla a esigere i dazi doganali federali che una convenzione di questo Stato aveva deciso di non applicare all’interno dei propri confini perché li riteneva troppo elevati e, quindi, dannosi per l’economia. Quando nel 1832 il Congresso varò una proroga ventennale del mandato della Second Bank of the United States, l’istituto finanziario dove il governo depositava il gettito fiscale dal 1816 ma secondo Jackson operava a vantaggio di una cricca di finanzieri contro i bisogni dei cittadini statunitensi, il presidente non si accontentò di porre il veto al provvedimento e iniziò anche a trasferire i fondi dello Stato federale in altre banche per affrettarne la liquidazione. Le tendenze autoritarie di Jackson, in nome di una presunta difesa degli interessi del popolo, furono così marcate che i suoi oppositori politici lo ribattezzarono Giorgio III, in riferimento al sovrano inglese il cui dispotismo nei confronti delle colonie nordamericane di Londra aveva innescato la guerra di indipendenza nel 1775.
Il retaggio illiberale
Proprio al sorgere degli Stati Uniti risale una corrente illiberale che vede in Trump la sua espressione più recente. Come affermò Benjamin Franklin, uno dei fondatori della nuova nazione sovrana, in una celeberrima risposta a Elizabeth Willing Powel, gli Stati Uniti della fine del Settecento intendevano essere una repubblica, non una democrazia. Non a caso, i costituenti idearono un complesso sistema di elezione indiretta del presidente, in parte ancora vigente, per separare il vertice delle istituzioni federali dall’espressione della volontà popolare. La repubblica non era neppure inclusiva perché promosse lo sterminio dei nativi americani, escluse le donne dalla politica fino alla concessione del suffragio femminile a livello federale nel 1920 e soprattutto fu espressione del suprematismo bianco, in quanto permise il mantenimento della schiavitù fino al 1865 e della segregazione razziale fino alla metà degli anni Sessanta del Novecento.
In particolare, la difesa dei privilegi della componente bianca della società statunitense ha costituito nel tempo uno dei principali terreni su cui sono state declinate le tendenze autoritarie del Paese. Il Ku Klux Klan, un’organizzazione terroristica creata alla fine della guerra civile per confinare gli schiavi afroamericani appena liberati ai margini della nazione, fu rifondato nel 1915, quando alle preesistenti istanze razziste aggiunse xenofobia e antisemitismo, e divenne una delle molteplici componenti della società statunitense che apprezzò il nascente fascismo nella prima metà degli anni Venti, riconoscendosi nel ricorso alla violenza politica e ai corpi paramilitari.
Da un successivo sviluppo di queste tendenze scaturì nel 1968 la candidatura alla presidenza dell’ex governatore democratico dell’Alabama George Wallace che, da indipendente, pur venendo sconfitto, conquistò gli Stati del profondo Sud, grazie a un programma incentrato sul ripristino della segregazione razziale, sulla minaccia di bombardare il Vietnam del Nord fintanto non fosse regredito all’età della pietra e sulla cancellazione degli aiuti di Washington per i Paesi emergenti. Un ex esponente del Ku Klux Klan, David Duke, non divenne governatore della Louisiana nel 1991 solo per una manciata di voti. Secondo la sociologa Michelle Alexander, l’odierna carcerazione di massa degli afroamericani – che, pur costituendo circa il 14% della popolazione totale degli Stati Uniti, rappresentano oltre un terzo dei detenuti – si configura come una forma di segregazione razziale sotto un’altra veste, comunque lesiva dei diritti fondamentali dei cittadini neri.
Make America white again
Alla volontà storica di marginalizzazione della comunità afroamericana e di esaltazione del suprematismo bianco si è rifatto Trump. Le revoche dei visti agli studenti colpiscono soprattutto quelli provenienti da Paesi africani e circa mezzo milione di rifugiati haitiani, che sono afro-discendenti, si è visto cancellare la protezione dalla deportazione accordata in precedenza dal democratico Joe Biden per ragioni umanitarie.
L’amministrazione federale, invece, si mostra disposta ad accogliere gli Afrikaners, cioè i discendenti dei colonizzatori boeri, che ritiene discriminati, se non addirittura perseguitati, dal governo del Sudafrica in quanto bianchi. The Donald si è anche reso portavoce di una più ampia operazione culturale sulla definizione della natura della società statunitense, già iniziata al tempo della sua prima presidenza.
Nel 2019, quattrocentesima ricorrenza della data (31 agosto 1619) che per convenzione aveva visto l’introduzione dei primi schiavi africani in quella che era l’America coloniale britannica, The 1619 Project, un’iniziativa di storiografia divulgativa patrocinata dal “New York Times”, sostenne che erano state le lotte degli afroamericani per l’abolizione della schiavitù, per l’abrogazione della segregazione razziale e per il conseguimento della parità dei diritti con i bianchi a realizzare negli Stati Uniti la democrazia nella sua pienezza, in quanto tali campagne avevano dato effettiva attuazione a quegli ideali di eguaglianza e libertà, formulati nel preambolo della Dichiarazione d’indipendenza del 1776, che altrimenti sarebbero rimasti una mera enunciazione retorica.
Di contro, a due giorni dalla conclusione del suo primo mandato alla Casa Bianca, il 18 gennaio 2021, Trump promosse The 1776 Report, un documento elaborato da una commissione presidenziale di storici per sottolineare la derivazione della democrazia statunitense esclusivamente dal pensiero illuminista europeo. Le celebrazioni del 250° anniversario della Dichiarazione d’indipendenza, che l’amministrazione Trump si prepara a organizzare in grande stile il prossimo anno, con tanto di inaugurazione di un giardino monumentale di statue raffiguranti 250 “eroi americani”, offriranno a The Donald un’ulteriore occasione per ribadire le radici europee e quindi bianche della nazione statunitense.
STEFANO LUCONI insegna Storia degli Stati Uniti d’America nel dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università di Padova. Le sue pubblicazioni comprendono La “nazione indispensabile”. Storia degli Stati Uniti dalle origini a Trump (2020), Le istituzioni statunitensi dalla stesura della Costituzione a Biden, 1787–2022 (2022), L’anima nera degli Stati Uniti. Gli afro-americani e il difficile cammino verso l’eguaglianza, 1619–2023 (2023). La corsa alla Casa Bianca 2024. L’elezione del presidente degli Stati Uniti dalle primarie a oltre il voto del 5 novembre (2024).