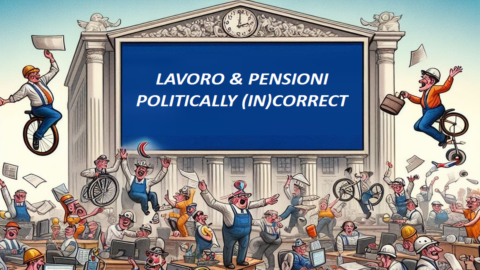Il Pci di cui celebriamo il centenario non è quello fondato a Livorno nel ’21 da Bordiga e Gramsci bensì quello ri-fondato a Salerno nel ’44 da Togliatti. Senza la svolta di Salerno il Pci, nel quale in tanti abbiamo militato e per il quale milioni di italiani hanno votato, semplicemente non sarebbe esistito.
Il Pci di Togliatti poggiava su due caposaldi: il primo era il legame con la Rivoluzione di ottobre e con il processo storico che quella rivoluzione aveva innescato su scala mondiale mondiale, il secondo era il Partito Nuovo e cioè un partito le cui caratteristiche fondamentali erano di non essere più il partito della sola classe operaia ma di essere interclassista, di non essere più un partito di soli quadri ma di massa e, soprattutto, di non essere di parte ma di apparire ed agire come il Partito della Nazione.
Il primo di questi due caposaldi, il legame con l’Urss, non è mai stato messo in discussione da nessuno: né da Togliatti, nè da Amendola e neppure da Berlinguer. Tutti i dirigenti del Pci erano convinti del fatto che la rivoluzione di ottobre, rompendo l’anello debole della catena dell’imperialismo (la Russia zarista), avesse messo in moto un processo di transizione dal capitalismo al socialismo su scala mondiale. Ed erano altresi convinti che, se quel processo avesse investito anche i paesi industrialmente più avanzati, il socialismo avrebbe assunto in occidente forme e caratteristiche ben diverse da quelle barbariche assunte nella Russia di Lenin e di Stalin. Per quanto grandi fossero gli errori e gli orrori di cui era disseminato, quel processo rappresentava comunque il primo passo concreto della transizione su scala mondiale dal capitalismo al socialismo. Come avrebbe detto molti anni dopo Brezniev, quello, piacesse o no, era il socialismo reale, il resto erano fantasie.
C’è voluta l’ammaina bandiera sul Cremlino perché il Pci prendesse finalmente atto del fatto che quel processo, giudicato positivo ed irreversibile, si era in realtà risolto in un clamoroso fallimento ed in una immane tragedia. Come sia stato possibile un simile abbaglio da parte di tanti è difficile da spiegare. Forse la spiegazione più vicina al vero l’ha data Christopher Hitchens nel suo Hitch-22: “…essere dentro quel processo dava (ai comunisti) la sensazione di sentirsi tutt’uno con la grande locomotiva della storia...di essere insomma nel giusto, qualcosa di veramente esaltante ma anche, a pensarci bene, di terribile…”
Diverso è il caso del secondo caposaldo, quello del Pci Partito della Nazione. Togliatti considerava il Pci come l’erede della tradizione democratica del Risorgimento (Garibaldi) e anche della migliore tradizione socialista, che non era certo quella massimalista, ma quella riformista delle leghe bracciantili, del mutualismo e della cooperazione, delle organizzazioni sindacali e delle Case del Popolo. Alla pari di Gramsci Togliatti riteneva che spettasse alle classi lavoratrici ed ai partiti che più le rappresentavano (comunisti, socialisti e cattolici) il compito di portare a compimento, attraverso profonde riforme sociali, quella rivoluzione liberale che la borghesia italiana aveva lasciato incompiuta e che, da ultimo, col fascismo, aveva tradito. A questo obiettivo storico era finalizzata la strategia del “Partito della Nazione”, poi codificata come via italiana al socialismo. Una strategia che per realizzarsi, presupponeva un profondo radicamento nella società, nelle fabbriche e nelle campagne, fra i ceti medi e gli intellettuali. Una strategia basata sulle riforme e su trasformazioni graduali, non certo su rotture rivoluzionarie. Ma, soprattutto, una strategia che per potersi affermare esigeva una partecipazione attiva delle masse ed una loro costante educazione politica. Ed è questo, forse, il maggior contributo che il Pci ha dato all’Italia e che oggi più ci manca. Nel Pci (a differenza dei partiti di oggi, e non solo i 5 Stelle o la Lega ) non c’era spazio per la demagogia o per il plebeismo, né per il populismo e il giustizialismo e, men che meno, per l’estremismo e il terrorismo. Tutte malattie, queste, che storicamente trovavano nella sinistra un terreno fertile su cui attecchire e che, proprio per questo, il gruppo dirigente del Pci combatteva con estremo rigore.
Naturalmente c’erano nel Pci ambiguità e reticenze, anche su questioni di fondo, che sono poi emerse nel momento in cui venne chiamato ad assolvere a compiti di governo negli anni ’70 e, ancora di più, quando negli anni ’80 la crisi del comunismo mondiale lo mise di fronte alla irrecusabile necessità di definire con chiarezza la propia identità e i propri obbiettivi.
In quest’ultima occasione il gruppo dirigente del Pci, che pure era formato da giovani come Occhetto, D’Alema e Veltroni non fu all’altezza del compito. Mancò di lucidità, di visione politica e di quel tempismo che invece Togliatti possedeva in sommo grado e che gli consentì di realizzare la svolta di Salerno. In questo caso, invece, la svolta non c’è stata e quella che Occhetto ritiene essere stata tale – quella della Bolognina – si è rivelata, alla luce della storia, una piroetta. Eppure, ripensandoci oggi, non sarebbe stato poi così difficile per dei quarantenni dire con chiarezza che quello che ancora ci si ostinava a chiamare comunista era in realtà, e già da tempo, un partito socialdemocratico, assai meno radicale del Labour inglese o del Partito socialista svedese; così come sarebbe stato semplicemente un atto di onestà politica da parte loro rivendicare il fatto che la politica economica e sociale del Pci era in realtà una politica riformista, volta cioè a risolvere i problemi dei lavoratori e del paese, e non certo finalizzata a costruire nuovi e improbabili modelli di sviluppo. Ma la cosa che avrebbe dovuto essere per loro più naturale fare, e che invece, volutamente, nessuno di loro ha fatto, sarebbe stato di accogliere, persino con gratitudine, l’offerta del Psi di avviare un processo di riunificazione delle “sparse membra”(come le chiamava Norberto Bobbio) del socialismo italiano, riunificazione che proprio il crollo del comunismo rendeva possibile. Si è persa una occasione storica. A quel gruppo di giovani turchi è mancato il coraggio di dichiarare chiusa l’esperienza storica del Pci e di compiere quelle scelte, dolorose ma necessari, che, forse, avrebbero consentito alla sinistra italiana di evitare la comune rovina.
Alla mancata svolta ha fatto seguito l’infelice stagione delle metamorfosi: dal Pds ai Ds sino all’odierno Pd. Una stagione caratterizzata dalla progressiva liquidazione della parte positiva dell’eredità del Pci (in particolare della sua vocazione unitaria) e dal riemergere dei suoi vizi peggiori: l’eterno complesso di superiorità per il fatto di sentirsi “dentro la locomotiva della storia”, il loro credersi moralmente superiori agli altri e persino geneticamente diversi ,il disprezzo per gli avversari, che nel caso di Craxi e Berlusconi ha rasentato l’odio, la corrività con il giustizialismo e, oggi, la permeabilità al populismo che spinge Goffredo Bettini a parlare di una alleanza strategica con i 5 Stelle di Beppe Grillo e Zingaretti a vedere in Conte un formidabile punto di riferimento per i riformisti. Una deriva impressionante!
Sbaglierò, ma sono convinto che questo epilogo sia dovuto alla leggerezza con la quale quel gruppo dirigente ha gestito la fine del Pci, alla loro incapacità di chiudere quella storia e di elaborare il lutto. Sono transitati dal comunismo al post comunismo con la stessa leggerezza con cui si beve un bicchiere d’acqua e di questa insostenibile leggerezza è figlio il PD che, non essendo un partito socialdemocratico e neppure un partito liberal democratico, rischia di non essere nulla e di rappresentare nell’Italia di oggi non il punto di forza della democrazia ma il suo anello debole.